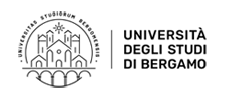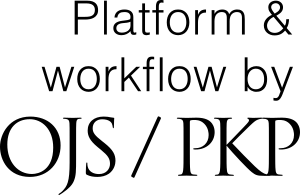Les prisons de l’art: zone di contatto tra complesso espositivo e arcipelago carcerario
Abstract
1. Les prisons de l’artNel novembre del 1899, sulla Revue des Deux Mondes, diretta da Ferdinand Brunetière, appare un originale contributo, denso di intuizioni, a firma di Robert de La Sizeranne e intitolato Les prisons de l’art.[1] Servendosi dell’immagine metaforica che rappresenta i musei come ‘prigioni dell’arte’, La Sizeranne stigmatizza le pratiche di musealizzazione che avevano caratterizzato le politiche culturali nelle maggiori città europee – come Parigi, Firenze, Avignone – durante gli ultimi tre decenni del XIX secolo. In linea con le posizioni espresse da John Ruskin, William Morris[2] e dalla critica d’arte di matrice estetizzante, in merito all’incompatibilità tra la conservazione di frammenti del passato nei musei e la demolizione di monumenti, edifici e quartieri storici, in seguito all’attuazione di piani di riordinamento urbano sviluppati sulla base degli ideali urbanistici del barone Haussmann (Vidler 2003: 164), La Sizeranne articola le sue riflessioni critiche a partire dall’analisi degli effetti decontestualizzanti prodotti da forzate acquisizioni museali. Camillo Sitte, in Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsatzen (L’arte di costruire le città, 1889), impiega l’accostamento tra prigioni e musei per evidenziare la circostanza irragionevole che porta a rinchiudere il bello e degradare esteticamente la città. “Le opere d'arte, anziché arricchire le piazze e le strade,” scrive Sitte, “si rifugiano in quelle prigioni che sono i musei” (Sitte 1953: 107). In Les prisons de l’art, contributo apprezzato da buona parte della critica coeva per la coerenza e forza argomentativa (Conti 1899; Beltrami 1904), La Sizeranne espande il nucleo delle riflessioni di Sitte in forma paradossale. Considera l’opera d’arte come dotata d’intrinseca vitalità, di una condizione esistenziale strettamente connessa al luogo per cui è stata creata. L’opera d’arte nel museo, privata del suo valore ambientale, separata dal contesto originario, dunque resa parzialmente leggibile, è vista come un segnale allarmante della rottura tra espressione artistica ed esperienza estetica quotidiana: lontana dalla vita, come in prigione.
La metafora estetico-carceraria delle ‘prigioni dell’arte’ trova una giustificazione genealogica in primo luogo nella zona di contatto tra enti museali e istituti detentivi, in quanto dispositivi disciplinari (Agamben 2006), ma anche nella coincidenza temporale tra due opposti fenomeni: il sensibile aumento tipologico e numerico dei luoghi espositivi nel XIX secolo e la diffusione delle tecnologie punitive di isolamento individuale in seguito alla creazione dei primi penitenziari cellulari, come Cherry Hill a Filadelfia nel 1824, quello francese di Mettray nel 1840, Pentonville a Londra nel 1842.
Il ‘secolo dei musei’, l’Ottocento, è stato anche il secolo delle prigioni. “Spazi altri”, spazi eterotopici (Foucault 2001; 2006), il museo e la prigione conoscono un momento di considerevole sviluppo all’interno di una società, come quella ottocentesca, ossessionata dalla storia, dal progresso tecnologico e dall’inesorabilità dei processi evolutivi: una società che “nel secondo principio della termodinamica”, nella definizione del concetto di entropia, “ha trovato gli elementi essenziali delle sue risorse mitologiche” (Foucault 2001: 19). Prigioni e musei rispondono, dunque, al bisogno di imporre un ordine disciplinare all’organismo della società attraverso la circoscrizione degli elementi ritenuti nocivi in eterotopie di deviazione, come i penitenziari, e la raccolta di documenti storici in eterotopie finalizzate all’accumulazione del tempo, come musei o biblioteche; eterotopie che funzionano come eterocronie, giacché sia i detenuti, in luoghi di passaggio funzionali ad una trasformazione e rigenerazione in senso morale, sia le testimonianze storico-artistiche, nel congelamento temporale all’interno di spazi immobili, “si trovano in una sorta di rottura assoluta con il loro tempo tradizionale” (Foucault 2001: 28).
Un ordine razionale è anche quello inciso nel vivo ventre storico di intricati e complessi sistemi urbani, risultato delle operazioni di demolizione di interi quartieri e apertura di ampi tracciati viari rettilinei. La rettificazione ottocentesca delle città proposta da Haussmann, “ artiste démolisseur”, appoggiata dal capitale finanziario del tempo ma soprattutto propugnata dai governi europei per la possibilità di ordinare la vita sociale attraverso l’ordine urbano, e impedire l’esplosione di rivolte ostacolando l’erezione di barricate con la creazione di larghi, luminosi boulevard, si qualifica come univoca soluzione alla necessità di adeguare le città agli standard della vita moderna e sanare le disastrose condizioni igieniche delle aree più antiche. Nelle grandi città del XIX secolo, lo sguardo dell’abitante è compresso nella fredda geometria di tali interventi, l’occhio è “letteralmente schiacciato da funzioni di sicurezza” (Benjamin 1962: 127). La Sizeranne attribuisce ai piani di "haussmannizzazione" le manifestazioni sintomatiche di una sempre più diffusa cecità nella comprensione del bello urbano come insieme omogeneo: l’innaturale separazione dell’arte dalla vita quotidiana, la chiusura di opere in mortificanti prigioni museali. La tipologia di manufatti artistici di cui La Sizeranne denuncia la prigionia nei musei ha infatti una ben precisa connotazione. Non è ai dipinti nelle collezioni private che rivolge la sua attenzione, poiché la presenza di una cornice già li separa dall’ambiente circostante. Inoltre, “un quadro può guadagnare molto da determinate disposizioni all’interno di una galleria, in un castello o in una cappella. Non perde tutto il suo fascino in un museo” (La Sizeranne 1904: 232). La Sizeranne opera una fondamentale distinzione tra arte imitativa e arte decorativa o applicata. Individua una categoria di manufatti artistici estremamente vitali nell’intima connessione con il contesto urbano, oggetti investiti di una funzione pubblica, quasi politica, di comunicazione dell’estetica delle città (La Sizeranne 1904: 232). E nell’interazione tra oggetto, ambiente, e soggetto che ne fa esperienza, La Sizeranne definisce l’obiettivo primario dell’arte decorativa, il valore d’uso e la sua dimensione esistenziale: “vivere della nostra vita e morire, se necessario, della nostra morte. A questo prezzo, insegna, affascina, consola. Altrimenti non fa che durare” (La Sizeranne 1904: 256). Vive forme d’arte, nella strada e per la strada, sono ridotte dal ‘piccone demolitore’ in frammenti; brani scultorei monumentali, sconnesse decorazioni pittoriche, il cui naturale ciclo vitale risulta irrimediabilmente interrotto e lo sviluppo materiale sospeso nei musei. La scissione della doppia condizione esistenziale ed estetica delle opere d’arte decorativa appare ineluttabile. Per La Sizeranne, la parola d’ordine dei sostenitori dei piani di modernizzazione delle città, mossi da ragioni economiche, sembra essere una sola: “L’utile in libertà, l’arte in prigione” (La Sizeranne 1904: 228). E “mentre si costruiscono musei, si distruggono opere d’arte. Si abbattono monumenti, a volte quartieri interi nelle città” (La Sizeranne 1904: 217). Alla ricchezza di accresciute collezioni museali fa da contraltare l’inevitabile perdita di fascino e bellezza delle strade.
Al depauperamento estetico del tessuto urbano non sfugge Parigi, capitale del XIX secolo e “luogo di pellegrinaggio estetico”, da metà Ottocento in preda ad una febbrile frenesia modernizzatrice: una città dove “si conserva e si distrugge con il medesimo accanimento” e dove ogni singolo frammento artistico recuperato dalle informi macerie, “il più piccolo brandello dipinto a colori è rinserrato, etichettato, conservato, escluso dalla vita pubblica [forclos]” (La Sizeranne 1904: 226). In questo breve passaggio, significativo è il ricorso ad un vocabolo inerente il campo semantico giuridico. La Sizeranne sceglie di usare il participio passato del verbo forclore per esprimere l’esclusione definitiva dalla sfera pubblica delle testimonianze artistiche musealizzate, alludendo quindi ad un immaginario carcerario nella sua dimensione burocratica e giurisdizionale. [3] Ma è nel sottolineare la condizione frammentaria delle opere d’arte raccolte nei musei che La Sizeranne attinge in maniera più schietta all’immaginario tradizionale della prigione. Nella presentazione di uno dei casi più emblematici di controversa musealizzazione, quello dei marmi Elgin, emerge l’immagine del corpo spezzato, a brandelli,[4] come quello di un prigioniero obliato in fosche segrete o sezionato su un tavolo d’obitorio:
Tetro come una prigione, piantato su colonne come un tempio, coronato di nebbie e appena discosto dalle case confinanti, ecco il massiccio nero del British Museum. È lì che sono detenuti i semidei. […] Su dei tavoli di marmo nero giacciono i resti di colossi che una volta risiedevano sui frontoni del Partenone: Elio, Teseo, Cerere, Proserpina, Iride, Selene, le Parche, la Vittoria, Prometeo, Minerva, Nettuno, Anfitrite, Leucotea, Cecrope, Mercurio… La vista di queste povere figure, mutilate come brandelli di corpi freddi sui lastroni degli obitori, serra il cuore. Poiché questi dei, anche se non regnano più con il loro potere su una manciata di credenti, dominano ancora il genere umano per la loro bellezza. Ma, qui recano le tracce di un inesplicabile e perfido abbandono, di una immemorabile empietà. (La Sizeranne 1904: 234)
Al centro di una delle sale del British Museum, la Cariatide pare una triste esule; separate membra di divinità o eroi della classicità sono sparpagliate in diversi musei; in alcuni casi, i loro “volti fatti per i baci delle dee”, giacciono in fondo ai mari, “in preda alle infette proboscidi di qualche spugna perforante” (La Sizeranne 1904: 235). Frammentarie testimonianze scultoree, classicheggianti anatomie, corpi marmorei smembrati, disposti su rigidi e regolari scaffali dagli zelanti ‘conservatori’ museali italiani del primo decennio del Novecento, compaiono anche in una vignetta disegnata da Libero Andreotti e pubblicata nel febbraio 1904 sul Marzocco [Fig. 1]. Rinchiuse in quei magazzini, depositi, o ‘prigioni dell’arte’, deprecati da La Sizeranne, le opere sembrano come bloccate nella posizione assegnata, senza relazione tra loro, esposte paratatticamente per il controllo degli operatori museali. Nella parte superiore del disegno di Andreotti, la fotografia ha il compito di registrare il ricordo dell’opera d’arte nel suo ambiente. Utilizzando un’immagine economica, lo stesso La Sizeranne considera le opere d’arte originali contenute nei musei come una sorta di ‘riserva aurea’ estetica da rendere fruibile e comunicabile in maniera semplice e pervasiva attraverso ‘cambiali o banconote’ fotografiche. [5] Bizzarra riflessione che lascia però scorgere in filigrana l’irriflessa intuizione del processo di mercificazione subito dall’opera d’arte, collegato da Benjamin (1966) al declino della sua aura a causa dell’accresciuta visibilità dovuta alla diffusione dei mezzi di riproduzione fotografica. “Avvertire l’aura di una cosa significa dotarla della capacità di guardare” (Benjamin 1962: 124), ma l’obiettivo fotografico, meccanismo che sembra produrre immagini come si stampano banconote, esclude l’eventualità di una restituzione dello sguardo. [6] L’opera d’arte in foto è resa inerte, incapace di interagire con l’osservatore e di far apparire quella sensazione di irripetibile distanza trasmessa dalla sua qualità auratica, percepita unicamente nella fruizione diretta dell’opera. Fissare fotograficamente lo sguardo sull’opera nel proprio luogo, per poi rinchiuderla in un museo, significa negarle la possibilità di ricambiare lo sguardo, di restituire se stessa investita della propria funzione comunicativa in risonanza con il contesto. “Dritte contro un fondo neutro e sciolte dalle fila delle loro vicine” (La Sizeranne 1904: 239), queste inaccessibili opere d’arte riprodotte in fotografia ricordano le foto segnaletiche dei condannati alla detenzione, utilizzate a partire dagli anni settanta del XIX secolo per schedare e catalogare la popolazione carceraria: uno sguardo neutro, affidato alla fredda oggettività del mezzo meccanico, che serba la memoria visuale di esseri viventi sottratti per periodi più o meno lunghi alla vista e alla vita [Fig. 2].
2. Complesso espositivo e arcipelago carcerarioTra la fine del XVIII e la prima metà del XIX secolo, si assiste al passaggio dalla spettacolarizzazione della pena, nella forma del supplizio pubblico, all’incarcerazione dei criminali nelle celle dei penitenziari. Il corpo del condannato, separato dalla società e reso invisibile allo sguardo pubblico, “lascia il campo della percezione quotidiana, per entrare in quello della coscienza attiva” (Foucault 1976: 11); non ha più la consistenza semiotica di manifestazione visibile dell’autorità punitiva del sovrano, ma è inserito nelle strette maglie di una microfisica del potere fondata sulla relazione simbiotica tra sapere e potere, sul controllo delle coscienze attraverso il controllo del corpo, sull’utilizzo di tecnologie di gestione del comportamento individuale: l’isolamento, la sorveglianza visuale continua, la segmentazione del tempo carcerario in una successione di attività alienanti, l’impiego di un sistema capillare di scritturazione e registrazione dei più minuti dettagli sulla vita dei detenuti. Intorno alla metà del XIX secolo, lo sviluppo di nuove strutture carcerarie fornì una risposta ai problemi di classificazione, ispezione e impiego lavorativo dei prigionieri, istanze sollevate dai sostenitori della riforma del sistema carcerario inglese, come John Howard e Jeremy Bentham, nell’ultimo ventennio del XVIII secolo (Ignatieff 1982; Evans 1982). L’isolamento individuale dei prigionieri sembrò la soluzione più ovvia ai fenomeni di corruzione e collusione delle guardie carcerarie, alla promiscuità e permeabilità delle celle settecentesche, alla diffusione di malattie tipiche del carcere – come la febbre tifoide, chiamata anche gaol fever (febbre della galera) – associata all’idea di contagio morale, di trasmissione fisica del vizio per contiguità. L’architetto William Blackburn, che lavorò a stretto contatto con Howard, mise a punto in complesse strutture architettoniche a pianta radiale un'efficace distinzione categoriale e funzionale dei locali, al fine di separare i detenuti per tipologie e distinguere gli spazi destinati al lavoro quotidiano da quelli per la reclusione. Ma fu con la prigione modello di Pentonville a Londra, progettata da Joshua Jebb, che si toccò il massimo grado di razionalizzazione architettonica corrispondente al rigido programma disciplinare cui erano sottoposti i detenuti: il completo isolamento; l’obbligo del silenzio; la scansione della giornata in attività fisse regolate dall’uso di sistemi meccanizzati; la spersonalizzazione e il controllo sulla libertà di visione. [7] I lavori per la costruzione del carcere di Pentonville iniziarono nel 1840 e l’edificio fu inaugurato nel 1842. La sua apertura richiamò nobili e uomini politici da tutta Europa, che visitarono il nuovo penitenziario ammirando la razionale articolazione spaziale dei fabbricati, i progressi tecnologici raggiunti nello sviluppo di servizi igienici individuali e innovativi impianti di termoventilazione e distribuzione automatizzata dei pasti [Fig. 3]. Soltanto nove anni dopo, gli stessi notabili d’Europa tornarono a Londra per contemplare, insieme ad un pubblico più eterogeneo, le meraviglie della produzione industriale mondiale, esposte dalle singole nazioni in occasione della Great Exhibition del 1851 [Fig. 4]. L’esposizione internazionale, la cui finalità politica consisteva nell’esaltazione del ruolo egemone del Regno Unito nel campo dell’industria, risultò vincente anche nel condensare le tecniche espositive specifiche del museo, del panorama, delle gallerie d’arte e dei passages, in un'efficiente forma di allestimento che consentiva di organizzare i visitatori e orientare i loro sguardi attraverso la disposizione ordinata degli oggetti (Bennett 1995: 61).
In un’illustrazione contenuta in The criminal prisons of London and scenes of prison life (1862), è possibile apprezzare un effetto di risonanza tra spettacolo della disciplina e spettacolarizzazione disciplinata: l’ora di visita al carcere di Clerkenwell è resa visivamente come una svagata passeggiata in una galleria commerciale, il bighellonare in un magasin de nouveautés, la visita al padiglione di un’esposizione internazionale [Fig. 5]. Ma la logica di chiusura visuale alla base del sistema penitenziario e la dinamica dello sguardo sollecitata dalle tecnologie di visualizzazione del “complesso espositivo”, tracciano traiettorie vettoriali inverse, hanno origine da un opposto movimento nello spazio. La forma disciplinare e penale dell’“arcipelago carcerario” attua uno spostamento del corpo del condannato dall’esterno verso l’interno, mentre un movimento dall’interno verso l’esterno interessa il complesso espositivo, come nel caso di opere d’arte provenienti da collezioni private e rese fruibili nei musei pubblici:
Due differenti insiemi di istituzioni e relazioni sapere/potere a loro associate, dunque, le cui storie, in questi termini, corrono in direzioni opposte. Eppure si tratta anche di storie parallele. Il complesso espositivo e l’arcipelago carcerario si sviluppano all’incirca nello stesso periodo – tra la fine del XVIII secolo e la metà del XIX secolo – e realizzano articolazioni complesse dei nuovi principi incarnati da entrambi in un decennio circa. (Bennett 1995: 61)
Un interessante fenomeno di coalescenza tra tecnologie della prigione e principi di ordinamento tassonomico che strutturavano le pratiche collezionistiche delle Wunderkammern o dei cabinets des curiosités [Fig. 6], è ravvisabile nell’allestimento di uno spazio espositivo aperto al pubblico ricavato in una cella del carcere di Millbank,[8] dove era possibile visionare gli strumenti usati per la tortura e la costrizione dei prigionieri fino alla fine del Settecento, disposti secondo un esplicito schema categoriale paratattico [Fig. 7]. Una sorta di gabinetto d’archeologia punitiva che testimonia il momento di transizione dalle oscure segrete, dalle umide e putride oubliettes nelle torri o nei sotterranei di castelli e caserme, alle parcellari celle individuali, spoglie, asettiche, del penitenziario rinnovato sul modello del carcere di Pentonville. Bennett osserva che esiste una rilevante “simbiosi simbolica tra lo sviluppo della carcerazione come principale forma moderna di punizione e la simultanea tendenza dei musei e di istituzioni simili ad includere le precedenti forme di pena nel loro repertorio di interessi rappresentazionali” (Bennett 1995: 153). Con la sottrazione del corpo del detenuto dallo spazio suppliziale pubblico, la legittimazione sociale delle scelte governative relative all’adozione delle tecnologie disciplinari del penitenziario è costruita attraverso l’ostensione dei sanguinosi eccessi punitivi del passato. Le prigioni trasformate in museo svolgono non solo una funzione politica a sostegno della nuova strategia detentiva, ma affermano anche l’identità dell’organismo statale sul piano della continuità storica. Nel saldare il presente espositivo al passato penale, il tessuto di storie che avvolge la prigione continua ad emergere anche dopo la riqualificazione dello spazio, e si frappone come un diafano velo durante l’esperienza di visita. La zona di contatto tra passato penale e presente museale consegna al pubblico la rivelazione di una sostanziale sovrapponibilità tra prassi differenti di gestione del potere e del sapere, di controllo sui corpi, di organizzazione funzionale degli spazi.
Nella descrizione del Palazzo del Bargello, contenuta nella sua Guida storico-artistica di Firenze, Federico Fantozzi introduce la storia dell’edificio come luogo di supplizio e carcerazione in una soggettiva dimensione esperienziale, quella del visitatore nella prima metà dell’Ottocento:
All’appressarsi che facciamo a questo tetro palazzo di barbara architettura, e che fu testimone di tanti strazi inumani, da’ quali la mente rifugge inorridita, ci sentiamo il cuore così concitato che, obliando il quieto e sincero vivere presente, ci sembra per un momento di essere avvolti nelle fazioni e ne’ tumulti di que’ secoli tempestosi […]. Quest’idea dolorosa si aumenta a misura che lo andiamo osservando, e nel momento che si pone il piede dentro il cortile, un brivido tremendo ci assale, e ci sembra di vederlo ingombro ancora di ributtanti sgherri, di zufoli, di dadi, di sbarre, di eculei, di capre, del ceppo del carnefice, della mannaia… ! Un istante però di reazione ci tranquillizza rammentandoci che quei tempi inumani trascorsero; che l’immortale Pietro Leopoldo regnò in Toscana, e che que’ trofei dell’umana barbarie furono nel luogo stesso ove per tanti secoli incrudelirono, arsi e distrutti. (Fantozzi 1842: 246-247)
Anche le sorelle Susan e Joanna Horner, britanniche, autrici della guida in due volumi intitolata Walks in Florence and its environs, furono rapite dal fascino particolare che avvolgeva il Palazzo del Bargello, “documento in pietra degli episodi più oscuri della storia fiorentina, salvaguardato durante il moderno processo di civilizzazione” (Horner 1884: II, 242). E la scura memoria dei sanguinosi episodi di cui il palazzo fu testimone, quasi inscritta nell’architettura, irrompe nella presentazione del salone d’ingresso e delle opere d’arte al suo interno:
Questa larga sala, con il soffitto voltato, che riposa su pilastri quadrati di solida muratura, fu per diverso tempo usata come camera di tortura, quando la piazza cessò di essere il luogo dell’esecuzione. La porta che dava sulla strada fu allora murata per evitare che i lamenti delle vittime fossero uditi. In un’acquaforte dell’incisore francese Callot, che rappresenta il Bargello e la vicina piazza durante un’esecuzione, si può notare un’altra porta al primo piano, comunicante con la Camera di Giudizio per mezzo di una scalinata che sale dalla strada. […] Vicino al pilastro centrale, che sorregge il soffitto e l’entrata, si trova una pietra quadrata che chiude la bocca di una fossa, dalla quale, negli ultimi anni, sono stati recuperati diversi cesti pieni di ossa, le quali erano tutte umane, con l’eccezione di alcune ossa di animali, sui quali potrebbe essere stata sperimentata questa oubliette. Questa sala contiene esempi di antiche armature […]. (Horner 1884: II, 249)
Il mutamento funzionale da prigione a museo, nel caso del Museo del Bargello, modifica le forme di interazione del corpo con lo spazio, e i “corpi primari”, quelli dei criminali torturati o rinchiusi nelle segrete dell’edificio fino al XVIII secolo, vengono sostituiti dai “corpi secondari” dei turisti del XIX secolo. La particolare esperienza estetica provata dai visitatori ottocenteschi, intuibile dalle parole di Fantozzi e delle sorelle Horner, deriva dall’attivazione di un legame protesico con gli oggetti e le tracce visuali del passato penale. Lo spazio di visita si configura come un nuovo testo ottenuto dalla reazione tra l’immaginario storico del visitatore e quello suggerito dalle pratiche curatoriali, che evidenziano gli elementi materiali e immateriali strutturanti la preesistente testualità del luogo (Terry 2010: 838-840). Durante la visita, il turista viene a trovarsi, dunque, in una sorta di spazio intertestuale e in una situazione di sovrapposizione identitaria: il visitatore di un museo ricavato da un luogo di prigionia condivide la medesima dimensione spaziale e percepisce le sfumature esistenziali della condizione dei detenuti, sembra dunque oscillare tra corporeità primaria e corporeità secondaria.
Georges Bataille definisce il museo come “lo specchio colossale in cui l’uomo finalmente contempla se stesso sotto ogni aspetto, si scopre degno di ammirazione, e si abbandona al sentimento estatico espresso in tutte le riviste d’arte” (Bataille 1930). Il vero contenuto del museo sono i visitatori che come liquido ematico vi fluiscono attraverso, per purificarsi e ossigenarsi nel grande polmone estetico delle gallerie espositive. Bataille ricorda inoltre un passaggio della Grande Encyclopédie, in cui è evidenziata la coincidenza temporale tra l’apertura del Louvre al pubblico e le prime teste troncate dalla lama egalitaria della ghigliottina. La giustapposizione tra un dispositivo che rende visibile la storia e una tecnologia suppliziale che cancella la storia dell’ancien régime, mette in luce la natura ambigua del museo moderno “impigliato tra la sua condizione architettonica di monument à mémoire e la sua funzione pubblica di machine à mémoire” (Vidler 2003: 177). Senza dubbio, ai principi libertari della rivoluzione francese si accompagnò una visione utilitaristica dell’accesso pubblico alla cultura e della funzione educativa dei musei, la qual cosa portò le istituzioni museali a configurarsi come sistemi disciplinari paragonabili alla scuola, all’ospedale, all’esercito, alla prigione (Hooper-Greenhill 2005: 199-226). Nell’introduzione di un apparato normativo finalizzato a coordinare il comportamento individuale all’interno dei musei si può riconoscere una sorta di ‘criminalizzazione’ del corpo dei visitatori e ‘militarizzazione’ degli spazi museali e delle opere in essi contenute.[9] I musei, le esposizioni internazionali, le fiere e le altre istituzioni del complesso espositivo, si rivelano dispositivi utili alla supervisione e gestione del comportamento individuale. L’instaurarsi di un intreccio biunivoco di sguardi, dovuto alla fondamentale condizione di duplicità dello spettatore, in quanto soggetto fruitore degli oggetti esposti e oggetto dello sguardo altrui [Fig. 8], attiva prassi imitative e consente il controllo del pubblico da parte degli stessi visitatori: “il museo incarna ciò che è stato, per Bentham, un obiettivo fondamentale del Panopticon – la democratica aspirazione di una società resa trasparente al proprio sguardo di controllo” (Bennett 1995: 101).
03. Prigioni dello sguardo“Il panottico, una forma dell’opera d’arte totale. L’universalismo del XIX secolo ha nel panottico il suo monumento. Pan-ottico: non solo si vede tutto, ma lo si vede in tutte le maniere” (Benjamin 2000: I, 594). Tecnologia di controllo visuale, rete che cattura e organizza lo sguardo [Fig. 9], il Panopticon, utopia-programma elaborata da Jeremy Bentham tra il 1787 e il 1791, si fonda su una dissimmetrica relazione visiva: dalla torre centrale il sorvegliante dirige lo sguardo simultaneamente su tutti i detenuti, ma la restituzione dello sguardo da parte loro è impedita da un sistema di persiane che scherma la sala di controllo, facendo apparire in controluce l’ispettore al suo interno come una elusiva “macchia completamente opaca” (Božovic( 1995). [10] Sfruttando un sapiente gioco di luci e ombre per occultare l’identità dei prigionieri e dei controllori, ma differenziandosi dalle tetre segrete per la priorità accordata alla piena visibilità della posizione e dell’attività dei condannati, organizzato sulla base di inflessibili principi ottici newtoniani, il Panopticon corrisponde omologicamente alla camera oscura, che struttura l’episteme visuale europea fino a metà Ottocento (Crary 2013: 28). E l’oculocentrismo del meccanismo panoptico appare plasmare i diagrammi progettuali nelle architetture della ‘visione totale’. È possibile infatti riscontrare una corrispondenza tra immagine planimetrica degli edifici panoptici e immagine schematica dell’organo coinvolto a livello fisiologico nel processo stesso della visione: l’intera macchina panoptica, concepita in forma circolare o ad emiciclo, come struttura a pianta centrale dal cui centro partono i raggi visivi del sorvegliante, assume una forma vicina a quella di un bulbo oculare, allucinato e senza palpebre, in uno stato di continua tensione scopica. Metonimia architettonica osservabile in progetti elaborati tra la fine del XVIII e la prima metà del XIX secolo: ad esempio, il penitenziario ideato da Harou-Romain [Fig. 10], che nel prospetto sembra un occhio sorgente dal terreno [Fig. 11]; la proposta fatta all’Accademia dei Georgofili di Firenze dal marchese Torrigiani [Fig. 12]; la nuova sede dell’Hôtel Dieu [Fig. 13], ospedale parigino,[11] disegnato da Poyet ma mai costruito, che poggia come un bulbo oculare sulle sponde dell’Île des Cygnes [Fig. 14]. Si può riscontrare l’impiego di uno sviluppo planimetrico secondo uno schema a pianta centrale anche nei primi progetti di museo ideale, come quelli di Boullée [Fig. 15] e di Durand [Fig. 16], nella quadrangolare Glyptoteck realizzata da Leo Von Klenze a Monaco (1816-1830), o l’adozione di una rotonda come punto focale del racconto museale, ad esempio nello spazio espositivo in cui l’architetto John Soane riconvertì la sua residenza londinese (1833), e nell’Altes Museum di Berlino progettato da K.F. Schinkel (1823-30); ma tali strutture architettoniche divergono per finalità progettuali dalla visione utilitaristica benthamiana di controllo totale, pur condividendone la matrice utopica. [12] “Fra le ragioni del prestigio accordato, nella seconda metà del secolo XVIII, alle architetture circolari”, osserva Foucault, “bisogna senza dubbio includere questa: esse esprimevano una certa utopia politica” (Foucault 1976: 190). Nella definizione architettonica di musei, prigioni e altri edifici panoptici, è dunque simile il ricorso a piante centripete, a una centralità nucleare intorno alla quale si condensa e consuma la dissimmetrica relazione visuale tra controllato e controllore, tra oggetto esposto e pubblico. Tuttavia, alla sincronia ottica dello sguardo ispettivo nel Panopticon, corrisponde un’organizzazione diegetica degli spazi museali: il centro del museo è spesso il cuore di una narrazione visiva che si dipana lungo le sale sulla base di una dinamica dello sguardo che inverte il principio panoptico, con la graduale messa a fuoco della folla di sguardi su singoli elementi spettacolari.[13]
La vitale Dorothée, Venere nera descritta da Baudelaire nel poemetto in prosa La belle Dorothée, solca rapida una spiaggia tropicale come una menade moderna, tra svolazzi di vesti leggere e a piedi nudi, perché “il piacere di essere ammirata prende in lei il sopravvento sull’orgoglio della libertà e, benché sia libera, cammina senza scarpe”. Nell’esporre allo sguardo altrui “il piede, simile ai piedi delle dee marmoree che l’Europa rinchiude nei suoi musei” (Baudelaire 1988: 59, corsivo mio), Dorothée, schiava affrancata originaria delle isole Mauritius, sembra rinunciare alla condizione di indipendenza raggiunta per dare libero sfogo alla sua naturale libertà. Dall’immagine, appena accennata, delle sculture recluse nei musei d’Europa, che Baudelaire associa al piede spoglio della fanciulla, si può trarre una duplice considerazione sul potere disciplinare dello sguardo: come la naturalità corporea riaffermata da Dorothée assoggetta nuovamente la fanciulla al mercificante sguardo coloniale, [14] così le pratiche di visualizzazione catturano lo sguardo dei visitatori e lo incatenano alle mura culturali che cingono le opere recluse nei musei.
Lo sguardo è intreccio di desiderio, potere e sapere, chiude il soggetto osservato, divenuto oggetto, in una gabbia, “figura della separazione senza mediazione: il soggetto è fianco a fianco con l’oggetto, il potere è fianco a fianco con l’impotenza. La gabbia è legata a un sapere trionfante che regna su un’ignoranza schiava” (Foucault 2004: 47). In una nota fotografia, il conte di Montizón cattura con il suo obiettivo l’ippopotamo Obaysch, scrutato con curiosità dal pubblico in piedi fuori della gabbia nello zoo di Regent’s Park a Londra [Fig. 17]. L’inquadratura scelta dal fotografo conferisce all’immagine una pungente ambiguità. Ciò che dovrebbe separare l’animale dai visitatori, stabilire i ruoli di soggetto e oggetto nella dinamica di sapere-potere attivata dall’ostensione dell’animale in cattività, favorisce in realtà l’intreccio di aporetiche relazioni visive: i visitatori schiacciati in secondo piano dalla griglia verticale delle barre metalliche appaiono come chiusi in gabbia, mentre l’animale, pur reificato dallo sguardo del pubblico, pare godere di maggiore libertà in uno spazio più ampio e vivibile. L’obiettivo fotografico verso cui alcuni dei visitatori rivolgono uno sguardo interrogativo che non viene ricambiato, li rende prigionieri di un potere visuale analogo a quello da loro esercitato sull’animale. E la loro passiva disposizione paratattica intorno alla gabbia ricorda quella dei prigionieri incatenati nelle segrete settecentesche, visibili, ad esempio, in una sintetica illustrazione della “fossa” nel carcere inglese di Warwick [Fig. 18], chiusa nel 1797. Uno schema analogo si può riconoscere nella posizione di spettatori seduti intorno ad una tecnologia ottocentesca d’intrattenimento visivo, il Kaiserpanorama [Fig. 19], o nelle sculture che occupano le nicchie e gli intercolunni della rotonda centrale nell’Altes Museum berlinese, dal cui cuore sembra irradiarsi una rete che lega in un vuoto scambio gli sguardi marmorei [Fig. 20]. Una paratassi circolare panoptica accomuna dunque detenuti, spettatori, opere scultoree nei musei, e consente di evidenziare l’elemento strutturante il rapporto pubblico/opera nella fruizione visuale, il rapporto sorvegliante/sorvegliato. Ciò che disciplina i prigionieri nei penitenziari, ciò che informa l’esperienza di visita e le scelte espositive nei musei, è sempre una centralità, visibile o opaca, sfuggevole o conoscibile, verso cui convergono o dai cui divergono gli sguardi presi nella ineludibile gabbia visuale: il centro controlla e regola lo sguardo, definisce le rispettive condizioni nella dissimmetrica relazione visuale instaurata tra soggetto e oggetto, assume la duplice funzione di “fulcro dell’esercizio del potere” e “luogo di registrazione del sapere” (Foucault 2002: 9).
Utilizzando il diagramma panoptico e vincolando il fruitore ad una posizione centrale, in Correction (2004) Fiona Tan attua un’inversione di ruoli: il sorvegliante diviene sorvegliato; lo spettatore è reso prigioniero dell’opera e di un intreccio di sguardi. L’artista olandese cinge il pubblico con video-ritratti di reclusi e guardie carcerarie, lo chiude tra immagini prelevate dall’universo della prigione; rendendo visibile ciò che solitamente è nascosto alla vista, libera i detenuti, dotandoli di uno sguardo [Fig. 21]. E nell’introdurre il mondo penale in uno spazio espositivo, sotto forma di opera videoartistica, Fiona Tan produce una vivida zona di contatto tra complesso espositivo e arcipelago carcerario; illumina la condizione di cattività condivisa da opera e pubblico, ambedue temporaneamente reclusi nel museo, dispositivo disciplinare e ‘prigione dell’arte’.
BibliografiaAGAMBEN G. (2006), Che cos’è un dispositivo, Nottetempo, Roma.
BATAILLE G. (1930), “Musée”, in Documents, II:5, p. 300.
BAUDELAIRE C. (1988), Lo Spleen di Parigi, SE, Milano.
BELTRAMI L. (1904), “Le prigioni dell’arte – Il monumento a Bernabò Visconti”, in Rassegna d’arte, IV:9, pp. 133-137.
BENJAMIN W. (1962), “Di alcuni motivi in Baudelaire”, in ID., Angelus Novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino, pp. 89-130.
BENJAMIN W. (1966), L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino.
BENJAMIN W. (1980), I “passages” di Parigi, a cura di Rolf Tiedemann, ed. it. a cura di Enrico Gianni, 2 voll., Einaudi, Torino.
BENNETT T. (1995), The Birth of the Museum. History, theory, politics, Routledge, London-New York.
BENTHAM J. (2002), Panopticon, ovvero la casa d’ispezione, a cura di M. Foucault e M. Perrot, ed. it. a cura di A. Fontana e M. Galzigna, Marsilio, Venezia.
BOŽOVIC( M. (1995), “An utterly dark spot”, in BENTHAM J., The Panopticon Writings, a cura di M. Božovic(, Verso Books, New York, pp. 1-27.
CONTI A. (1899), “Le prigioni dell’arte”, in Il Marzocco, IV:41, p. 1.
CRARY J. (1999), Suspensions of perception: attention, spectacle and modern culture, MIT press, Cambridge (Massachusetts).
CRARY J. (2013), Le tecniche dell’osservatore. Visione e modernità nel XIX secolo, Einaudi, Torino.
DUBBINI R. (1980), “Carcere e architettura in Italia nel XIX secolo: tecnologia punitiva e strategie spaziali”, in MORACCHIELLO P., TEYSSOT G. (a cura di), Le macchine imperfette: architettura, programma, istituzioni nel XIX secolo, Officina Edizioni, Roma, pp. 218-244.
DUBBINI R. (1986), Architettura delle prigioni. I luoghi e il tempo della punizione (1700-1880), Franco Angeli, Milano.
EVANS R. (1982), The fabrication of virtue. English prison architecture, 1750-1840, Cambridge University Press, Cambridge.
FANTOZZI F. (1842), Nuova guida ovvero descrizione storico-artistico-critica della città e contorni di Firenze, Firenze. (Ristampa anastatica, Forni Editore, Bologna 1974).
FOUCAULT M. (1976), Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino.
FOUCAULT M. (2001), “Spazi altri”, in VACCARO S. (a cura di), Spazi altri. I luoghi delle eterotopie, Mimesi, Milano, pp. 19-32.
FOUCAULT M. (2002), “L’occhio del potere. Conversazione con Michel Foucault”, in BENTHAM J., Panopticon, ovvero la casa d’ispezione, Marsilio, Venezia, pp. 7-30.
FOUCAULT M. (2004), “Un sapere così crudele”, in ID., Scritti letterari, Feltrinelli, Milano, pp. 41-54.
FOUCAULT M. (2006), “Le eterotopie”, in MOSCATI A. (a cura di), Utopie Eterotopie, Cronopio, Napoli, pp. 11-28.
GIEBELHAUSEN M., “The architecture is the museum”, in MARSTINE J. (a cura di), New Museum Theory and Practice: an introduction, Blackwell Publishing, Oxford, pp. 41-63.
HAROU-ROMAIN N.-P. (1840), Projet de pénitencier, Imprimerie de Lesaulnier, Caen.
HOOPER-GREENHILL E. (2005), I musei e la formazione del sapere, il Saggiatore, Milano.
HORNER S. e J. (1884), Walks in Florence and its Environs, 2 voll., Smith, Elder & Co., London.
IGNATIEFF M. (1982), Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese. 1750-1850, Mondadori, Milano.
LA SIZERANNE R. de (1899), “Le prisons de l’art”, in Revue des Deux Mondes, CLVI:11, pp. 114-138.
LA SIZERANNE R. de (1904), Les questions esthétiques contemporaines, Hachette, Paris.
MAYHEW H., BINNY J. (1862), The criminal prisons of London and scenes of prison life, Griffin, Bohn & Co., London.
McCLELLAN A. (2002), “From Boullée to Bilbao. The museum as utopian space”, in MANSFIELD E. (a cura di), Art History and its Institutions. Foundations of a Discipline, Routledge, London, pp. 46-64.
McCLELLAN A. (2008), The art museum from Boullée to Bilbao, University of California Press, Berkley-Los Angeles-London.
MILLER J.-A. (1987), “Jeremy Bentham’s Panoptic Device”, in October, 41, estate 1987, pp. 3-29.
POHL N., “Passionless reformers: the museum and the city in utopia”, in GIEBELHAUSEN M. (a cura di), The architecture of the museum. Symbolic structures, urban contexts, Manchester University Press, Manchester, pp. 127-143.
OLIN M. (1996), “Gaze”, in NELSON R.S., SHIFF R. (a cura di), Critical Terms for Art History, The University of Chicago Press, Chicago & London, pp. 208-219.
SANYAL D. (2006), The Violence of Modernity: Baudelaire, Irony and the Politics of Form, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
SITTE C. (1953), L’arte di costruire le città, Vallardi, Milano.
TERRY A. (2010), “Criminals and Tourists. Prison History and Museum Politics at the Bargello in Florence”, in Art History, XXXIII:5, pp. 837-855.
TORRIGIANI C. (1841), Tre dissertazioni sul diritto di punire applicato come mezzo di repressione e correzione, Tip. Gregorio Chiari e figli, Firenze.
VIDLER A. (2003), “The space of history: modern museum from Patrick Geddes to Le Corbusier”, in GIEBELHAUSEN M. (a cura di), The architecture of the museum. Symbolic structures, urban contexts, Manchester University Press, Manchester, pp. 160-182.
SitografiaAGLIARDI N. (2012), “L’immaginario del frammento nelle prigioni novecentesche di Céline”, in Elephant & Castle, 7, http://cav.unibg.it/elephant_castle/web/saggi/l-immaginario-del-frammento-nelle-prigioni-novecentesche-di-celine/113, scaricato il 25/03/2013.
LEE P. (2003), “Eye and Gaze”, in MITCHELL W.J.T., ALMEIDA E. de, REYNOLDS R. (a cura di), Keywords of Media Theory, University of Chicago, http://csmt.uchicago.edu/glossary2004/eyegaze.htm, ultima visualizzazione il 15/06/2013.
LOCATELLI PREDA M. (2012), “John Keats: l’ansia scolpita negli Elgin Marbles”, in Elephant & Castle, 7, http://cav.unibg.it/elephant_castle/web/saggi/john-keats-l-ansia-scolpita-negli-em-elgin-marbles-em/109, scaricato il 25/03/2013.
TAN F. (2004), Correction, http://www.fionatan.nl/works/15, ultima visualizzazione il 21/07/2013.
[1] L’articolo, leggermente rivisto e ampliato, fu riedito nel volume Les questions esthétiques contemporaines (Le questioni estetiche contemporanee, 1904), che contiene cinque saggi in cui La Sizeranne discute la natura estetica delle pratiche artistiche oggetto del dibattito critico tra fine Ottocento e primo Novecento: l’utilizzo del ferro in architettura; le problematiche relative alla traduzione scultorea delle forme variegate della moda; il ruolo e l’identità della fotografia come arte; le ricerche cromatiche dei pittori impressionisti; il confino dell’arte nelle stanze delle nuove istituzioni museali. Tutte le citazioni da Les prisons de l’art si riferiscono a questa seconda edizione del testo. Inoltre, sia per le citazioni dal contributo di Robert de La Sizeranne sia per quelle tratte da testi in inglese o francese, di cui in bibliografia non è indicata un’edizione italiana, la traduzione è da considerarsi come mia.
[2] La Sizeranne fu un profondo conoscitore della produzione pittorica inglese del suo tempo, attento e aggiornato sull’attività artistica del movimento Arts & Crafts. Il suo studio La Peinture anglaise contemporaine (1895) è un testo fondamentale e imprescindibile per l’analisi della ricezione critica dell’arte britannica nella Francia di fine Ottocento. Inoltre, è noto che fu la lettura di Ruskin et la religion de la beauté, pubblicato da La Sizeranne nel 1897, a introdurre Marcel Proust al pensiero di John Ruskin.
[3] Nel Dictionnaire de moyen français, il verbo forclore designa la privazione da un diritto, l’esclusione da un beneficio. In una lettera inviata a Pierre-Joseph Thoulier, abate di Olivet, Voltaire ricorre al participio passato forclos per descrivere la situazione in cui è impossibile accedere ad una città le cui porte sono chiuse, e precisa che si tratta di una “parola molto espressiva che non ha dimora se non nell’avvocatura” (citato in Philologie française ou Dictionnaire étymologique. Tome premier 1831: 615).
[4] Sul legame tra immaginario del corpo in frammenti e immaginario della prigione si rimanda al saggio di Nicola Agliardi (2012), pubblicato nel numero 7 di Elephant & Castle. Nello stesso numero, si veda inoltre il contributo di Marica Locatelli Preda (2012), in cui è analizzato il frammento On seeing the Elgin Marbles di John Keats.
[5] “Si percepisce meglio il loro insieme in una buona fotografia, in cui il fondo è stato unificato, piuttosto che all’interno del museo, tra lo scintillio dei colori. Molti dei capolavori sono conosciuti da noi meglio in questo modo, per mezzo delle loro fotografie, che avendone un’esperienza visiva diretta. Non sono altro che la ‘riserva’ estetica le cui rappresentazioni fiduciarie percorrono l’Europa. Si sa che esistono, ma, in realtà, non le si è mai viste” (La Sizeranne 1904: 239-240).
[6] Come osserva Walter Benjamin in Di alcuni motivi in Baudelaire: “ciò che nella dagherrotipia doveva essere sentito come inumano, e starei per dire micidiale, era lo sguardo rivolto (e per giunta a lungo) all’apparecchio, mentre l’apparecchio accoglie l’immagine dell’uomo senza restituirgli uno sguardo. Ma nello sguardo è implicita l’attesa di essere ricambiato da ciò a cui si offre” (Benjamin 1962: 124).
[7] Ad esempio, l’utilizzo di maschere marroni, aperte unicamente in corrispondenza degli occhi, impediva il riconoscimento del volto del prigioniero durante gli spostamenti in gruppo dalla cella alla cappella per il servizio religioso oppure durante l’ora d’aria (Mayhew-Binny 1862: 141; Ignatieff 1982: 5-6; Evans 1982: 361-362, fig. 191).
[8] Una curiosa coincidenza ha voluto che sullo stesso sito dove sorgeva la prigione di Millbank, demolita nel 1892, venisse costruito l’edificio per esporre al pubblico la consistente raccolta di opere d’arte di Sir Henry Tate, nucleo fondante la collezione della National Gallery of British Art, oggi Tate Britain, aperta nel 1897.
[9] Comincia ad essere regolata l’affluenza nei musei e l’accesso ad un pubblico indifferenziato con la definizione di giorni e orari di apertura e chiusura; inoltre, viene impiegato personale di sicurezza e custodia nelle sale, si introducono norme di condotta in maniera più o meno esplicita, come la ‘regola del silenzio’, la cui osservanza, obbligatoria nelle prigioni, appare naturale, invece, negli spazi museali, come forma di rispetto per la sacralità delle opere d’arte e per non recare disturbo agli altri visitatori. I beni culturali sono disposti nelle sale sulla base di precisi criteri museotecnici di collocazione spaziale e illuminazione, e di nuovi criteri museologici nella segmentazione cronologica dei manufatti in scuole o nella suddivisione tematica in soggetti. Nascono discipline e pratiche specifiche, come la storia dell’arte e il restauro, e la nuova istituzione museale travalica i confini nazionali, assumendo una configurazione reticolare e transnazionale attraverso un regime interconnesso di scambi che “impone un ampio sguardo museologico incrociato che giudica e sorveglia le collezioni di Francia e dei territori conquistati” (Hooper-Greenhill 2005: 220), sulla base di un’articolazione geografica che sovrappone la mappa museale europea a quella militare.
[10] Il progetto benthamiano si fonda sull’idea di controllo totale: chi controlla deve a sua volta essere controllato. Bentham stabilisce una distinzione gerarchica tra gradi di sorveglianza e considera l’apertura occasionale a visitatori esterni sia a scopo educativo sia come strumento di garanzia sul corretto funzionamento dell’intero sistema e di vigilanza sugli stessi ispettori: “do per scontato che essendo state prese le misure necessarie per prevenire ogni evasione e disordine, le porte di questo edificio debbano essere, come dovrebbero esserlo in tutti gli edifici pubblici salvo ragioni speciali, spalancate alla folla dei curiosi al grande comitato pubblico del tribunale del mondo” (Bentham 2002: 51). Tutti i soggetti che entrano a far parte della macchina panoptica sono dunque vincolati al potere disciplinare dello sguardo. Tuttavia, tale forma di immanente controllo totale non intacca il principio dissimmetrico di unilateralità della visione: il singolo controlla una moltitudine di soggetti, ma non può essere simultaneamente controllato da coloro che lui stesso controlla. Anche in quello che si definisce “Panopticon inverso”, quando è una moltitudine di soggetti a controllare il singolo, è conservata una relazione visiva unilaterale: all’oggetto dello sguardo è preclusa qualsiasi possibilità di restituzione dello stesso.
[11] Bentham mirava ad estendere la sua idea progettuale ad istituzioni diverse dalle prigioni, che tuttavia condividono con il penitenziario la natura di dispositivi disciplinari, come scuole, case di correzione, fabbriche, o di spazi eterotopici, appunto ospedali e manicomi (Bentham 2002: 81-103).
[12] La descrizione della cupola nel palazzo della conoscenza, elemento centrale di una sorta di spazio museale del futuro, che s’incontra nel romanzo ucronico di Louis-Sébastian Mercier, L’An 2440, rêve s’il en fut jamais (L’anno 2440, 1771), esercitò un’enorme influenza sugli ideali progettuali di Durand e dei suoi epigoni. L’immaginario dello stesso Mercier si nutrì degli scritti utopistici di Johann Valentin Andreae (Christianopolis, 1619), Tommaso Campanella (La città del sole, 1623), Francis Bacon (New Atlantis, 1627), in cui sono presentate fantasiose istituzioni pubbliche protomuseali, finalizzate all’accumulo di testimonianze culturali e alla divulgazione del sapere (McClellan 2002, 2008; Pohl 2003). Inoltre, come evidenzia McClellan (2002: 48), Francis Bacon esprime la centralità del luogo in cui è concentrata la produzione e diffusione del sapere nella sua utopica città, chiamandolo il “vero occhio [very eye]” della comunità ideale descritta.
[13] Nel dimostrare come alcune tecnologie della visione assumono una forma eminentemente architettonica, Tony Bennett contrappone alla prigione e all’ospedale psichiatrico un’architettura simbolo del “complesso espositivo”, il Crystal Palace, in cui risulta invertito il principio di ordinamento dello sguardo. Come sostiene Graeme Davison (citato da Bennett 1995: 65): “il Crystal Palace rovesciò il principio panoptico nel concentrare gli sguardi della moltitudine su un insieme di merci alla moda. Il Panopticon era concepito in maniera tale che ognuno potesse essere visto; il Crystal Palace fu progettato in maniera tale che ognuno potesse vedere” (DAVISON G., “Exhibitions”, in Australian Cultural History, 2, 1982/1983, p. 7).
[14] Debarati Sanyal sostiene che “La belle Dorothée lascia intravedere la violenza della rappresentazione del corpo nero allo stesso tempo come natura primordiale e merce esotica” (Sanyal 2006: 128). E il parallelismo paradossale tra il corpo di Dorothée e le bianche Veneri marmoree diventa funzionale all’instaurazione di una specularità tra “l’incarnazione vivente di una primitiva età dell’oro” e “l’età classica custodita gelosamente nei musei d’Europa” (Sanyal 2006: 125).

Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza
Copyright (c) 2023 Elephant & Castle

TQuesto lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.