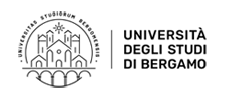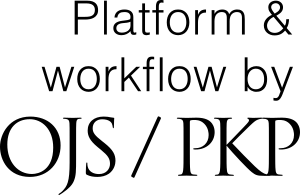Il conflitto arabo-israeliano dietro le sbarre: ripensando a Meahorey Ha-Soragim di Uri Barbash
Abstract
Nel corso degli ultimi anni il cinema israeliano ha conosciuto una notevole fortuna in ambito internazionale, in un crescendo di successi che ha portato anche sugli schermi del nostro Paese le opere dei cineasti più apprezzati dello Stato ebraico. Come la critica ha notato, quella che la produzione cinematografica d’Israele sta vivendo è un’autentica età dell’oro (Grant 2008) di cui, finalmente, anche gli spettatori internazionali possono godere, sebbene la distribuzione spesso non arrivi a coprire tutti film davvero meritevoli d’interesse e molti di essi rimangano di solito nei circuiti dei festival di cultura ebraica o nei cinema d’essai. Nonostante la felice situazione attuale, già negli anni ’80 furono realizzate pellicole notevoli, che meriterebbero tutt’oggi di essere sottoposte all’attenzione del grande pubblico. Tra queste non si può prescindere da Meahorey Ha-Soragim[1] (Beyond the walls), uscito nel 1984 per la regia di Uri Barbash, con la sceneggiatura di Benny Barbash e di Eran Preis, il quale per molte ragioni può essere considerato antesignano di numerosi lungometraggi realizzati recentemente, insieme ad altri film straordinari prodotti nello stesso periodo. In realtà Meahorey Ha-Soragim a suo tempo ebbe un certo risalto anche in ambito internazionale. Vincitore del premio della critica al Festival del Cinema di Venezia del 1984, fu nominato agli Oscar come miglior film straniero. Oggi, tuttavia, è per lo più noto ai soli esperti del settore. Si tratta di una perdita di enorme rilievo per il pubblico non israeliano, giacché il film offre spunti di riflessione unici.
A rendere eccezionale questa pellicola è, in primo luogo, il fatto che le vicende si svolgano all’interno di un carcere di massima sicurezza. Esso è, finora, il solo film israeliano interamente ambientato in una prigione. Questo dato, a parte il valore puramente statistico, ha un’importanza sostanziale. La scelta di collocare gli eventi tra le mura di un penitenziario offre, infatti, una lettura preziosa della società israeliana. Come vedremo, sebbene dal film sembri emergere soltanto la contrapposizione tra arabi ed ebrei, Meahorey Ha-Soragim presenta, invece, una trama complessa, che mira a descrivere, attraverso la metafora della prigione, la natura conflittuale della società d’Israele, non da ultimo il difficile rapporto tra le due principali etnie ebraiche: gli ashkenaziti e i sefarditi (o mizrahim).[2]
Meahorey Ha-Soragim descrive la vita in carcere di prigionieri israeliani e arabi, questi ultimi reclusi per lo più per reati politici connessi al terrorismo. I due personaggi principali sono il mizrahi Uri (Arnon Zadok), un delinquente abituale [fig. 1] che ben presto diviene il “capo” degli israeliani, e Issam (Muhammad Bakri), leader del gruppo arabo-palestinese [fig.2], condannato a numerosi ergastoli per aver preso parte ad attentati e azioni terroristiche contro la popolazione ebraica. Gli animi dei prigionieri si scaldano per l’arrivo di Assaf [fig. 3 e fig. 4], un ex-militare colpevole di aver intrattenuto contatti con l’OLP (interpretato da Assi Dayan, figlio del leggendario uomo politico Moshe Dayan). Issam vorrebbe che il nuovo arrivato fosse messo in cella con lui e gli altri arabi, mentre gli israeliani (tra i quali vi sono criminali comuni, un tossicodipendente, un cantautore soprannominato Ha-Zamir, “l’Usignolo”, e uno strambo prigioniero sempre accompagnato da un pappagallino che sembra essere un’allusione all’ornitologo di Alcatraz, Robert Stroud[3]) si rifiutano di accoglierlo e promettono violenze e ritorsioni. Il signor Hershkovitz (Hillel Ne'eman), il responsabile della sicurezza del penitenziario, minaccia i detenuti che, se si ribelleranno, farà annullare la partecipazione de “l’Usignolo” al festival della canzone, programmata per i giorni successivi [fig. 5]. Per rispetto verso il compagno il gruppo promette di comportarsi bene ma la tensione è palpabile. Il signor Hershkovitz si rivela un manipolatore corrotto: egli ha a proprio servizio un giovane arabo e un detenuto israeliano, Hoffman (Haim Shinar), i quali operano per lui in segreto all’interno della prigione, gestendo anche il traffico di stupefacenti. Nel momento in cui Hoffman comincia a diventare scomodo e pericoloso, Hershkovitz lo fa uccidere. I prigionieri israeliani, convinti che siano stati gli arabi ad assassinare Hoffman, danno libero sfogo alla propria rabbia. A seguito degli scontri, Issam e Uri, gettati in cella d’isolamento, si confrontano per la prima volta e sembrano avvicinarsi. Nel frattempo il signor Hershkovitz ricatta Doron, un giovane dai tratti femminei in precedenza stuprato crudelmente da un compagno di cella, spingendolo a testimoniare contro gli arabi riguardo l’omicidio di Hoffman, con la minaccia di restituirlo al proprio aguzzino. Disperato, Doron s’impicca, lasciando, però, un biglietto in cui svela la verità su Hershkovitz. I prigionieri si rendono finalmente conto che lo scopo del responsabile della sicurezza è di fomentare l’odio tra le due parti, affinché non s’instauri tra di esse una pericolosa solidarietà. In virtù della nuova consapevolezza, i carcerati superano i conflitti etnici e politici che li dividono per unirsi in uno sciopero della fame contro l’amministrazione della prigione [fig. 6]. Alcuni di loro pagano un caro prezzo: Assaf si ammala gravemente e Issam rinuncia a incontrare la moglie e il figlioletto mai conosciuto [fig. 7] pur di non cedere ai ricatti di Hershkovitz.
Meahorey Ha-Soragim è innanzitutto un prison movie (o film carcerario), esplicitamente ispirato a celebri esempi del cinema occidentale, in particolare di quello americano. Gli autori sembrano, infatti, aver studiato a dovere il genere cinematografico riproducendone meccanismi, personaggi e temi ricorrenti. Tuttavia, ad un attento sguardo risulta chiaro che non si tratta di una semplice imitazione di noti cliché (le violenze, le guardie brutali, gli stupri, le droghe ecc.) ma dell’utilizzo di una cornice facilmente riconoscibile dallo spettatore, finalizzata all’approfondimento di una vicenda del tutto specifica alla realtà di Israele. Sebbene Meahorey Ha-Soragim possa essere considerato un “solido esempio di genere” (Thomas 1985, traduzione mia), ogni topos citato assume un senso peculiare alla situazione precisa di cui si narra, radicalmente inserita nella realtà sociale d’Israele. Esso è un film corale dove, nonostante una maggiore attenzione dedicata ai leader, Uri e Issam, si muove un vasto numero di personaggi i quali contribuiscono a creare l’allegoria su cui si basa l’intera vicenda. Nella pellicola di Barbash, infatti, il carcere non rappresenta se stesso ma la società israeliana nella sua complessità. Non è certamente una scelta innovativa; si potrebbero citare numerosi esempi analoghi nell’ambito della cultura occidentale, soprattutto in campo letterario e cinematografico. Eppure si tratta di un’idea assolutamente inedita per gli schermi israeliani, la quale si rivela essere una metafora perfetta, giacché descrive in maniera molto convincente i conflitti e le tensioni che si sviluppano tra gruppi etnici diversi costretti a vivere in perenne stato di tensione entro confini territoriali angusti come quelli dello Stato ebraico.
Inoltre, la sceneggiatura sembra rielaborare l’intuizione foucaultiana della prigione come metafora per le modalità di esercizio del potere e della sorveglianza sui cittadini nella società moderna. In Meahorey Ha-Soragim la prigione diviene allegoria del controllo e dei metodi disciplinari che il sistema del potere esercita sugli individui attraverso una manipolazione sottile ed esperta. Esso manovra sapientemente i desideri, i bisogni e le fobie dei cittadini, li istiga l’uno contro l’altro o li pacifica secondo le proprie necessità, tramite meccanismi subdoli di cui la popolazione è del tutto inconsapevole. Il sistema del potere vede, conosce, sorveglia, disciplina ed esegue, penetrando direttamente nel corpo dei prigionieri-cittadini i quali sono pedine di un gioco che li vuole ignari e asserviti. Citando sempre Foucault, nella prigione, così come in luoghi analoghi:
il corpo umano entra in un ingranaggio di potere che lo fruga, lo disarticola e lo ricompone. Una “anatomia politica”, che è anche una “meccanica del potere”, va nascendo. Essa definisce come si può far presa sui corpi degli altri non semplicemente perché facciano ciò che il potere desidera, ma perché operino come esso vuole, con le tecniche e secondo la rapidità e l'efficacia che esso determina. La disciplina fabbrica così corpi sottomessi ed esercitati, corpi “docili”. (Foucault 1976:150)
Nel film ciò si realizza, ad esempio, tramite la droga che, lungi dall’essere un semplice strumento di fuga dalla terribile realtà del carcere, come nel noto In the Name of the Father (Nel nome del padre, 1993), costituisce, invece, una forma di dominio e di anestetizzazione fisica e mentale, di cui Hershkovitz dichiara in modo esplicito l’utilità: “Le droghe, Hoffman, qua dentro ci sono sempre state e sempre ci saranno! Non le abbiamo inventate né io né te. Sono l’ossigeno della prigione e per me sono un mezzo per dominarli, per preservare la quiete!” Malgrado ciò, “i corpi investiti da queste tecniche di potere non sono docili e immobili oggetti di cui poter disporre liberamente, essi sono individui che oppongono resistenza, e che ribadiscono con forza i propri valori” (Mescoli 2010:72). Il film carcerario, per definizione, “mette in scena l’uomo che si ribella all’ingiustizia” (Guerri 1998:85) e, come dimostra la sua trama, Meahorey Ha-Soragim non è da meno. In un momento ben preciso della vicenda i protagonisti sono posti di fronte a un dilemma fondamentale: reagire e far valere i propri diritti o continuare a essere fantocci del sistema. Nel film il processo di presa di coscienza e la successiva ribellione dei prigionieri sono graduali e seguono il lento dipanarsi degli eventi. Uri e gli altri devono comprendere l’uguaglianza della propria condizione di esseri umani oppressi, prima di riuscire a superare l’odio e la paura reciproca instillati in loro dal sistema stesso. Nonostante sia considerato per antonomasia come uno strumento di massificazione, il carcere di Barbash mira a preservare le differenze etniche, politiche e linguistiche tra i singoli, individuando nella divisione tra i prigionieri e nel mancato riconoscimento della loro misera condizione di esseri umani il segreto per la propria sopravvivenza. Un fugace momento di solidarietà si verifica durante le riprese del festival della canzone, eccezionalmente trasmesso in diretta dal carcere per consentire all’Usignolo di esibirsi con Tni li yad, “Tendimi una mano”. La canzone ha un testo piuttosto semplice e tradizionale: un uomo torna col pensiero alla casa che è stato costretto a lasciare, immersa in un paesaggio idilliaco, fatto di rose e colombe. Egli immagina di volare per poter ricongiungersi all’amata, cui chiede di tendergli una mano capace di calore e sostegno. Sebbene sia cantato solo in ebraico, il brano commuove e coinvolge anche i detenuti arabi, giacché il linguaggio universale della musica tocca sentimenti di nostalgia e bisogno di affetto condivisi da tutti i presenti. Malgrado il riferimento a un personaggio femminile, il testo esprime un evidente desiderio di libertà e la richiesta di una mano tesa può essere interpretata in senso metaforico come una timida invocazione iniziale di avvicinamento all’altro che si attuerà nel finale in un sentimento di solidarietà tra sfruttati. La canzone, infatti, è destinata a tornare anche nelle ultime battute del film, quando tutti i detenuti, deboli ma certi della propria vittoria morale [fig. 8], ne mormoreranno insieme la melodia. Durante il festival, però, la notizia di un attentato contro gli israeliani rompe l’incanto, ridefinisce i confini tra i prigionieri e li riporta all’interno delle rispettive fazioni, scatenando rabbia e tensione nel carcere. A capovolgere la situazione sarà la tragica morte di Doron, il quale, con il suo volto infantile e delicato, ricorda l’immagine del fanciullo martire, immolatosi per il bene comune. Tramite il suicidio egli rivela ai carcerati la realtà della prigione, spingendoli a lottare per la propria dignità di esseri umani. La ribellione si traduce, come abbiamo visto, in uno sciopero della fame, il quale rappresenta il rifiuto di essere alimentati ancora da un sistema oppressore e violento, interrompendo il legame di dipendenza fisica e materiale da esso. È questo il senso dell’accorato discorso pronunciato da Uri in sala mensa che sintetizza il contenuto dell’intero film:
Guardo queste persone che ora interrompono lo sciopero e mi dico: forse loro sono migliori. Perché, chi sono io? Quando avevo solo tredici anni si sarebbe potuto aprire una biblioteca pubblica con i miei fascicoli giudiziari. Perché allora? Perché? Perché dove sono nato il solo modo di rimanere liberi era rubare a propria volta la libertà. E anche qui si può essere liberi. Essere liberi significa scegliere: scegliere se essere fedeli a se stessi o fare il loro gioco. Essere i loro burattini. Ci sono due tipi di burattini. Ci sono i burattini che sanno di esserlo e ci sono gli altri burattini. Quelli che se ne stanno seduti a mangiare e ingozzarsi come maiali e solo loro, di sopra, sanno che sono i loro burattini. (traduzione mia)
Sia le parole sia i gesti di Uri durante la scena alludono a una gerarchia verticale, che pone l’amministrazione del carcere sulla sommità, mentre i detenuti si trovano sul fondo, come marionette sovrastate dallo sguardo del burattinaio manipolatore.
È chiaro che il significato allegorico di questa vicenda rispetto al conflitto arabo-israeliano appare particolarmente forte. L’ostilità tra arabi ed ebrei sarebbe, quindi, frutto di lucide e crudeli manovre da parte di una classe politica e dirigente dedita solo ai propri interessi e, soprattutto, indifferente alla conclusione di un accordo di pace. Il conflitto tra i due popoli, infatti, è il pane di cui il potere si nutre, mantenendosi stabile e sicuro. In assenza di esso, si aprirebbe una voragine di pericolosa libertà sociale, temibile soprattutto per le istituzioni. Tuttavia, il fatto che alla fine del film ebrei e arabi si uniscano in una strenua lotta contro questa forma di potere induce nello spettatore internazionale, il quale spesso non conosce le intricate e minuziose dinamiche della società d’Israele, la convinzione che Meahorey Ha-Soragim mostri soltanto le possibilità di collaborazione e di solidarietà tra due popoli divisi da un conflitto apparentemente insanabile, gli israeliani e i palestinesi. Ne sono una testimonianza le recensioni pubblicate su riviste e quotidiani europei e americani, le quali parlano per lo più di “un’allegoria sulle relazioni arabo-israeliane che invoca la riconciliazione” (Thomas 1985, traduzione mia) o di “un ramoscello d'ulivo cinematografico che dimostra la possibilità per arabi ed ebrei di unirsi in vista di un obiettivo comune” (Russell 1985, traduzione mia). Benché queste considerazioni non possano dirsi del tutto errate, esse non colgono completamente il reale sostrato del film. La struttura gerarchica della prigione, dove da una parte vi è chi comanda e opprime, dall’altra chi subisce ed è oppresso, ha, in realtà, delle implicazioni etniche molto più precise. Il crudele signor Hershkovitz, col suo cognome di chiara origine slava, non rappresenta solo il potere in senso generico, ma incarna un preciso tipo di potere in Israele, quello degli ebrei europei o ashkenaziti. Principali rappresentanti del Sionismo classico, essi hanno eretto la maggior parte delle istituzioni politiche e governative e hanno gestito e guidato a lungo la nazione divenendo l’élite del Paese. Uri e la maggior parte dei prigionieri israeliani sono, invece, chiaramente mizrahim; essi appartengono, cioè, a un gruppo etnico ebraico privo di mezzi che la classe politica europea-ashkenazita ha a lungo trascurato, escludendoli di fatto dai ruoli di comando.[4] Insieme a Issam e ai detenuti arabi, rappresentanti del popolo palestinese privato della propria terra, essi costituiscono gli oppressi di Israele, coloro i quali sono stati per troppo tempo sottoposti a un’autorità cieca e scaltra. La solidarietà tra i popoli capace di sovvertire le sorti del conflitto, sembra suggerire il film, può realizzarsi in particolare tra questi due gruppi, i mizrahim e gli arabi, i quali condividono, oltre a comuni radici linguistiche e culturali, un passato di sfruttamento e di soprusi. Meahorey Ha-Soragim, con la sua allegoria della prigione, sembrerebbe, pertanto, suffragare alcune teorie sviluppatesi negli ultimi decenni, secondo cui gli ebrei mizrahim e i palestinesi hanno subito in Israele un tentativo di soppressione, in nome di una totalizzante ideologia sionista:
La negazione da parte dei Sionisti degli arabi-musulmani e palestinesi ha, quindi, come corollario la negazione degli ebrei mizrahim, che, come i palestinesi, ma ovviamente con meccanismi più sottili e meno brutali, sono stati spogliati anch’essi del diritto di auto-rappresentazione. All'interno di Israele e agli occhi dell’opinione mondiale, la voce egemonica d’Israele è stata quasi sempre quella degli ebrei europei, gli ashkenaziti, mentre la voce dei mizrahim è stata in gran parte ridotta o messa a tacere. (Shohat 2004:39, traduzione mia)
Sebbene il conflitto con gli arabi sia assolutamente palpabile durante tutta la pellicola, in Meahorey Ha-Soragim le tensioni più violente e crudeli riguardano proprio ashkenaziti e mizrahim. A questo riguardo sembra avere un’importanza basilare il motivo dello stupro, un topos ricorrente in molti prison movies, il quale nel nostro film assume anch’esso un valore simbolico e descrive in maniera esclusiva i rapporti tra le due etnie ebraiche, com’è palese sin dalla scena iniziale. Meahorey Ha-Soragim si apre con il rituale dell’ingresso in prigione. Ciò nonostante, a differenza di quanto avviene in numerose pellicole che “tendono a focalizzarsi su un nuovo arrivato sbattuto in galera per aver commesso un crimine di poco conto e costretto, quindi, a soffrire sotto un sistema brutale” (Alber 2007:2, traduzione mia), i minuti introduttivi del nostro film mostrano non il primo contatto di un principiante atterrito con il sistema penale ma il ritorno a casa di un visitatore regolare: Uri. Il prigioniero si spoglia e le mani esperte di una guardia eseguono la perquisizione. La telecamera indugia a lungo sul corpo di Uri, il quale è sezionato e analizzato con una lentezza morbosa e ossessiva, una parte dopo l’altra. Come sostiene Raz Yosef, questa spettacolarizzazione del corpo di Uri lo rende, di fatto, un corpo “femminile” (Yosef 2004:109), esposto a una possibile penetrazione violenta, che nella mente del prigioniero si concretizza nell’esame anale cui le guardie lo vogliono sottoporre. Uri, l’ebreo mizrahi, percepisce l’ispezione come una minaccia alla propria sessualità che lo costringerebbe a piegarsi di fronte al dominio ashkenazita, il quale “nega la sua forza di maschio e lo trasforma in un ricettacolo femminile del proprio potere maschile” (Yosef 2004:110, traduzione mia). Non a caso la scena è posta all’inizio della pellicola. Il rientro in carcere rappresenta, infatti, per Uri un nuovo e frustrante ritorno sotto il potere dei suoi dominatori e afferma ancora una volta “l’umiliazione sociale” dell’ebreo mizrahi (Yosef 2004:110, traduzione mia). La penetrazione anale, più o meno violenta, è, dunque, parte dell’allegoria dell’oppressione sociale dei mizrahim ed è una paura concreta nella mente di questi ultimi, i quali percepiscono in modo distorto, paranoico, omofobico ogni relazione omosessuale. Uri reagisce con aggressività, minacciando un infermiere con un bisturi ed è subito portato in cella d’isolamento, dove le guardie lo picchiano selvaggiamente.
L’importanza di questo tema in Meahorey Ha-Soragim è stata esaminata con cura da Raz Yosef nel volume Beyond Flesh. Queer Masculinities and Nationalism in Israeli Cinema (2004) e non è mia intenzione ripercorrere qui, nel dettaglio, le diverse fasi della sua scrupolosa analisi. Va comunque ricordato che nel corso del film l’ allegorizzazione sessuale è ulteriormente spostata dal conflitto sociale a quello politico e definisce, inoltre, il contrasto tra mizrahim e ashkenaziti riguardo alla questione palestinese. Secondo Yosef, l’omofobia (e quindi l’omosessualità repressa) che sembra caratterizzare Uri e i personaggi simili a lui nel film è una metafora per il loro antagonismo violento nei confronti del processo di pace con gli arabi[5] (Yosef 2004:110). Ne è un esempio l’ingresso in cella del collaborazionista Assaf, il tipico attivista della sinistra israeliana: colto, educato e, soprattutto, ashkenazita, molto diverso dagli altri detenuti ebrei. Fitussi, un tossicodipendente anch’egli sefardita, si mostra molto ostile nei suoi confronti e cerca addirittura di stuprarlo, ma è fermato dall’intervento di un compagno di cella. Per Fitussi, il collaborazionismo di Assaf si sdoppia in due atti omosessuali ben precisi: da un lato egli “se la fa” con i palestinesi, dall’altro, pratica uno stupro territoriale e ideologico nei confronti degli israeliani, cosa che la sessualità patologica dei mizrahim ritiene di dover punire con un analogo castigo.
Dal canto suo, la figura di Assaf riabilita in qualche modo gli ashkenaziti, il cui onore nel film è svilito dal crudele Hershkovitz. Dopo averlo inizialmente considerato un traditore della patria, i suoi compagni arriveranno a capire l’importanza della conciliazione con gli arabi, finendo, di fatto, per sostenere le idee pacifiste di Assaf. Quest’ultimo, ovviamente, partecipa allo sciopero e paga con la salute (e forse anche con la vita, come ci lascia intendere il regista) la propria dedizione: reso debole e malato dal digiuno, egli rifiuta ogni cura, con il pieno supporto di Uri. Sebbene riscatti la propria etnia di appartenenza, Assaf mostra, però, che per ottenere una piena riabilitazione gli ashkenaziti devono sacrificare totalmente se stessi, cessando di essere i freddi e insensibili burocrati dell’establishment per riprendere, invece, le vesti classiche del pioniere delle origini d’Israele, generoso, appassionato e sprezzante della morte.
Essendo una “prigione etnica” (Thomas 1985, traduzione mia) la rappresentazione dei diversi gruppi ebraici è, dunque, una questione fondamentale per la comprensione di Meahorey Ha-Soragim. Questo aspetto del film ha sollevato, tuttavia, anche qualche polemica, soprattutto da parte della critica vicina alla cultura sefardita. Come abbiamo visto, Uri e i suoi compagni mizrahim sono, infatti, tradizionalmente raffigurati come delinquenti omofobi o feroci estremisti, ed essi devono compiere un notevole lavoro di autoanalisi per arrivare alla consapevolezza finale. Ella Shohat, in particolare, ha biasimato le scelte del regista, affermando che Barbash non ha saputo affrancarsi dalla rappresentazione scontata dell’ebreo mizrahi, il quale nel film rimane sempre e comunque un criminale dei bassifondi (Shohat 1989:271), secondo il peggiore degli stereotipi. Ben diversa è, invece, la descrizione degli arabi, in particolare di Issam, la quale merita un’attenzione particolare, giacché ci conduce a un altro aspetto fondamentale del film.
Oltre a essere un film carcerario, per la storia del cinema israeliano Meahorey Ha-Soragim riveste anche un altro importante ruolo. Esso rientra, infatti, nel fenomeno che Ella Shohat ha identificato, talvolta ironicamente, come “Gal Falastini” o “Palestinian Wave” (Shohat 1987:10). Con questa definizione s’intende l’ampio numero di film sul tema del conflitto arabo-israeliano prodotto nello Stato ebraico tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, sull’onda di eventi d’importanza fondamentale quali il “ribaltone” del 1977, che portò al governo per la prima volta la destra di Menachem Begin, la Prima Guerra del Libano (1982) e la Prima Intifada (1987). Sebbene l’espressione “Palestinian Wave” sia stata coniata per il cinema, essa è del tutto adatta a descrivere lo straordinario cambiamento che investì anche altri settori della cultura dello Stato ebraico, portando la narratività israeliana a colmare la sua più grave lacuna: la pressoché totale assenza degli arabi da essa. Il fenomeno investì, infatti, anche la letteratura, sebbene in quest’ultimo ambito vi fossero già stati alcuni decenni prima esempi degni di nota, per quanto sporadici e abbozzati (Ramras-Ra?ukh 1989 e Scardi 2000: 214-236). Fu un cambiamento enorme, i cui effetti sono visibili tutt’oggi, sia nel cinema sia nella letteratura. A ogni modo, fino a quel momento poche erano state le opere dedicate al conflitto e molto rari i personaggi arabi inclusi nel discorso narrativo israeliano. Inoltre, la rappresentazione di questi pochi era per lo più “incompleta, faziosa, distorta e presentata da una prospettiva occidentale condiscendente” (Preminger 2012:412). Come scrivono anche Alberto Brodesco e Davide Mano:
Nemico in casa, figura ideologicamente negativa, minaccia onnipresente ma allo stesso tempo invisibile, l'arabo nella narrativa israeliana (cinematografica e non) è rimasto costretto in una condizione di non conoscibilità, adottando talvolta il profilo indefinito di un uomo senza voce, o restando schiacciato entro facili stereotipi orientalistici, relitto di un popolo del deserto fiero ma selvaggio. Il difficile rapporto con la minoranza araba è stato così riassorbito dal gruppo dominante ebraico all'interno di una dinamica di attrazione/repulsione, in cui “l'altro” arabo è stato “percepito da una parte come nobile e generoso e dall'altra come incolto, instabile e violento”. (Brodesco, Mano 2010:33)
Da questo momento in poi gli arabi non furono più raffigurati come “nemici anonimi” (Shohat 1987:12) la cui presenza era in funzione esclusiva del protagonista israeliano, ma divennero personaggi autonomi e pensanti, provvisti di una precisa identità culturale, etnica e linguistica. Inoltre, essi furono spesso rappresentati come oggetto di un amore struggente e proibito per la parte israeliana o come figure dall’animo nobile, fortemente impegnate nella lotta per i propri diritti nazionali, con le quali lo spettatore è invitato a identificarsi. Gli israeliani, invece, sono spesso personaggi duri e insensibili che necessitano una lunga elaborazione per arrivare a comprendere l’altro. Durante questa fase la rabbia e la lotta del popolo palestinese non solo trovarono, quindi, una prima eccezionale espressione sullo schermo del “nemico”, ma ne furono anche legittimate.
Come ogni film appartenente alla “Palestinian Wave”, Meahorey Ha-Soragim partecipa, dunque, di tutte queste caratteristiche, senza tralasciarne nessuna. In questo preciso contesto, la figura di Issam è particolarmente simbolica. Interpretato, com’è già stato detto, dal palestinese Muhammad Bakri, il quale fu scelto dal regista per ribaltare ogni stereotipo esteriore concernente gli arabi (Uryyan 1997:44) - l’attore è alto, con gli occhi azzurri e la carnagione chiara - egli è circonfuso da un’aura solenne e grave, quasi mistica e, pur essendo, di fatto, un terrorista, appare un uomo nobile e serio, mai eccessivo sebbene sia pronto a sacrificare ogni interesse personale per servire la causa del proprio popolo. A questo proposito, va segnalato che Bakri intervenne direttamente nella sceneggiatura la quale, nella sua forma originale, prevedeva che alla fine del film Issam cedesse ai ricatti di Hershkovitz e si ritirasse dallo sciopero per andare incontro alla moglie e al figlio. L’attore suggerì, invece, al regista che la figura di Issam sarebbe stata più coerente nella sua integrità se, dopo aver compiuto pochi, brevi passi verso la famiglia, avesse fatto ritorno in cella per continuare la lotta (Liebes 1994:31). In effetti, il risultato finale, molto efficace, sembra dargli ragione.
Nella sua idealizzazione, il personaggio di Issam è l’esempio più evidente del totale rovesciamento di ruoli operato nel film. Egli, infatti, appare molto più vicino alla figura dell’eroe romantico, codificato dal cinema israeliano nel genere eroico-nazionalistico, [6] di quanto non lo sia Uri o qualunque altro personaggio ebreo. Come abbiamo già visto, al di là delle connotazioni etniche, i prigionieri israeliani costituiscono gli abitanti tipici di ogni penitenziario e sono per lo più “associati al crimine, alla depravazione sessuale, alla tossicodipendenza. Pertanto, tutti gli stereotipi della società israeliana secondo cui gli arabi sono intellettualmente e moralmente inferiori agli ebrei, sono, in definitiva, rovesciati” (Bartov 2005:275, traduzione mia). Secondo Aner Preminger, invece,
il tentativo di spezzare una rappresentazione stereotipata avviene a costo di creare un nuovo stereotipo, contrario a quello precedente. Muhammad Bakri ha l'aspetto di un Paul Newman palestinese. Per molte ragioni il film rafforza una lettura stereotipata dei personaggi, dal momento che l’eccezionalità mimetica di Bakri lo porta a essere percepito come un’eccezione che conferma la regola: vale a dire che solo gli arabi simili a lui sono umani, personaggi tridimensionali. (Preminger 2012:417, traduzione mia)
Parafrasando il titolo di un noto saggio di Yehuda Ne’eman (Ne’eman 1991) potremmo sintetizzare le parole di Aner Preminger con la frase “Aravi tov hu aravi baseret”, ossia “l’arabo buono si trova nei film”. L’eccessiva paradigmaticità di Issam lo renderebbe, dunque, un personaggio poco credibile, adatto solo a una rappresentazione fittizia, lontana dalla reale storia quotidiana del conflitto. In effetti, si tratta di un’ingenuità facilmente riscontrabile in molte pellicole della Palestinian Wave, spesso frettolose, dopo decenni di silenzio, di mostrare la bontà quasi assoluta del nemico. Ciò nonostante, non ci si può esimere dal considerare che la presenza nel cinema d’Israele di arabi positivi e consapevoli sotto il profilo politico e intellettuale, contrapposti a israeliani intolleranti, dubbiosi e/o violenti, fa parte di una volontà profonda di autoanalisi la quale, com’è già stato accennato, ha preso corpo durante gli anni ’80. Gli eventi occorsi durante questo decennio, particolarmente sanguinosi e discussi, hanno costretto gli israeliani a ripensare se stessi valutando nuovamente il proprio ruolo nel territorio e il proprio rapporto con l’altro, soprattutto con i palestinesi. E il mondo della cultura, i cui esponenti appartenevano per lo più alla sinistra politica pacifista, si è impegnato fermamente su questa linea. A questo riguardo, Meahorey Ha-Soragim ha svolto senza dubbio un ruolo di grande rilievo e, seppur ingenue, le scelte del regista rivestono una sicura importanza storica avendo, inoltre, aperto la strada ad affascinanti personaggi arabi che si possono incontrare in pellicole recenti, come la risoluta Salma Zidane (Hiam Habbass), protagonista di Etz Limon (in italiano, Il giardino di limoni, 2008) diretto da Eran Riklis.
La complessità della struttura di Meahorey Ha-Soragim è, quindi, considerevole, molto più di quanto non appaia a una prima visione, e il suo significato è rilevante su diversi piani. Barbash, infatti, elabora il tema della prigione in maniera da trasformare il topos universale della lotta dell’uomo contro le ingiustizie e le prevaricazioni nell’analisi suggestiva di uno dei più sanguinosi e tragici scontri della storia contemporanea. L’attenzione a prospettive di norma omesse, o non dovutamente esaminate, come il coinvolgimento all’interno del conflitto arabo-israeliano dei contrasti tra le diverse etnie ebraiche, è una prova della serietà di questa operazione cinematografica, che sceglie di non abbracciare cammini già battuti ma di intraprendere, piuttosto, percorsi innovativi, almeno per Israele. L’intento di offrire uno spaccato veritiero delle reali tensioni che attraversano lo Stato ebraico e, al tempo stesso, di offrire una possibilità di soluzione, si realizza in modo perfetto nell’allegoria del carcere, luogo di segregazione e di ostilità, di conflitto e di angoscia, ma anche di catarsi e di rinascita. Malgrado, forse, alcune piccole mancanze, Meahorey Ha-Soragim dimostra come anche un genere così definito e, per molti aspetti, ripetitivo quale il film carcerario possa essere rielaborato in modo originale e reso un valido strumento d’indagine delle strutture sociali, più o meno imperfette, di un Paese.
BibliografiaALBER J. (2007), Narrating the Prison: Role and Representation in Charles Dickens' Novels, Twentieth-Century Fiction and Film, Cambria Press, Youngstown.
BARTOV O. (2005), The "Jew" In Cinema: From The Golem To Don't Touch My Holocaust, Indiana University Press, Bloomington.
BRODESCO A., MANO D. (2010), “L'obiettivo, lo specchio, il mirino. Lo sguardo sull'arabo del cinema israeliano”, in Cinergie. Il cinema e le altre arti, 20, pp. 33-37.
FOUCAULT M. (1976), Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino.
GONTHIER D. (2006), American Prison Film Since 1930: from The Big House to The Shawshank Redemption, Edwin Mellen Press, Lewiston.
GRANT L. (2008), “Out of the shadows”, in The Guardian, 18 novembre 2008, http://www.guardian.co.uk/world/2008/nov/18/israel-film-ica-animation, consultato il 22 luglio 2013.
GUERRI A. (1998), Il film noir. Storie americane, Gremese Editore, Roma.
KRONISH A., SAFIRMAN C. (2003), Israeli Film: a Reference Guide, Praeger Publishers, Westport.
LIEBES T. (1994), “Debating the portrayal of the other as one of us: Palestinians in the new Israeli cinema”, in Jewish Folklore and Ethnology Review, XVI:1, pp. 30-34.
SHOHAT E. (2004), “Sephardim in Israel: Zionism from the Standpoint of its Jewish Victims” in McLINTOCK A., MUFTI A, SHOHAT E. (2004), Dangerous Liaisons: Gender, Nations, and Postcolonial Perspectives, University of Minnesota Press, Minneapolis.
MESCOLI E. (2010), Sul mio corpo. La circoncisione femminile in un'analisi di contesto, Interscienze, Milano.
Ne’eman y. (1991), “Aravi tov hu aravi baseret”, in Maariv, 8 settembre 1991, http://www.amalnet.k12.il/sites/commun/library/cinema/comi0380.htm, consultato il 22 luglio 2013.
Preminger a. (2012), “The Arab Other in Israeli Cinema and Discourse”, in Journalism and Mass Communication, February 2012, Vol. 2, No. 2, 412-420.
Ramras-Ra?ukh G. (1989), The Arab in Israeli Literature, Indiana University Press, Bloomington.
RUSSELL C. (1985), “Bitter Foes Move Beyond Animosity In Intense Walls”, in Sun Sentinel, 17 maggio 1985, http://articles.sun-sentinel.com/1985-05-17/features/8501200083_1_israeli-film-maximum-security-prison-uri-barbash, consultato il 22 luglio 2013.
SCARDI R. (2000), “Il lato in ombra di Israele: la figura dell’arabo nella letteratura israeliana” in Bidussa D., Collotti Pischel E., SCARDI R. (2000), in Identità e storia degli ebrei, Franco Angeli, Milano.
SHOHAT E. (1987), “The Return of the Repressed: the Palestinian Wave in Recent Israeli Cinema”, in Cineaste, XV:3, 10-17.
SHOHAT E. (1989), Israeli Cinema: East/West and the Politics of Representation, University of Texas Press, Austin.
THOMAS K. (1985), “Beyond The Walls: Ethnic Prison”, in Los Angeles Times, 23 febbraio 1985, http://articles.latimes.com/1985-02-23/entertainment/ca-1018_1_arab-prisoners, consultato il 22 luglio 2013.
URYYAN D. (1997), The Arab in Israeli Drama and Theatre, Harwood Academic Publishers, Amsterdam.
YOSEF R. (2004), Beyond Flesh: Queer Masculinities and Nationalism in Israeli Cinema, Rutgers University Press, Piscataway.
[1] L’enorme successo di botteghino e di critica, ottenuto soprattutto in Israele, spinse il regista a girare un sequel, Meahorey Ha-Soragim 2 (1991), il quale ebbe, però, esiti tutt’altro che esaltanti. In questo breve studio Meahorey Ha-Soragim 2 non è preso in considerazione, data la sua scarsa originalità rispetto al precedente.
[2] Con l’aggettivo mizrahi, letteralmente “orientale”, sono designati gli ebrei israeliani originari dei Paesi Arabi, i quali incontrarono gravi difficoltà economiche e sociali al loro arrivo nello Stato ebraico. Costretti spesso a vivere in condizioni disagiate, si scontrarono, in modo anche violento, con la classe politica dominante di provenienza per lo più europea (o ashkenazita).
[3] Robert Stroud fu un criminale americano che, durante la permanenza in prigione, si dedicò allo studio degli uccelli creandosi una fama di ornitologo. La sua storia è narrata in Birdman of Alcatraz (L’uomo di Alcatraz), uscito nel 1962 e interpretato da Burt Lancaster. A parte la vicenda specifica di Stroud, la presenza nelle celle di piccoli animali con cui alcuni prigionieri stringono un legame profondo non è inusuale nei film carcerari, come testimonia anche il celebre The Green Mile (Il miglio verde, 1999).
[4] Negli ultimi decenni la situazione è, però, molto cambiata e molti mizrahim rivestono ruoli pubblici di grande rilievo.
[5] La convinzione che i sefarditi o mizrahim siano particolarmente ostili al processo di pace è uno stereotipo ben radicato nella cultura israeliana, sebbene frutto di un’evidente generalizzazione spesso smentita dalla realtà dei fatti.
[6] Il genere eroico-nazionalistico si è sviluppato in seguito alla Guerra d’Indipendenza del 1948 tramite pellicole che trattavano in particolare la nascita dello Stato d’Israele e la lotta per la patria ebraica.

Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza
Copyright (c) 2023 Elephant & Castle

TQuesto lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.