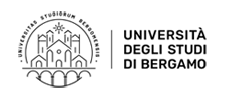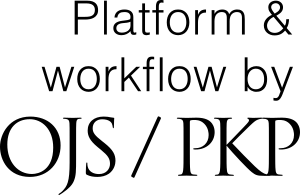Light on the wall: a dialogue
Abstract
Era il 23 settembre 2011, l’anno delle primavere arabe, quando il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas, presentò formalmente all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la richiesta di ammissione della Palestina come Stato membro dell’organizzazione. Mentre una buona parte del mondo arabo che si affaccia sul Mediterraneo era in fermento per individuare nuovi percorsi di organizzazione politica e civile dopo il crollo dei regimi in Tunisia, Egitto e Libia, la richiesta palestinese ha fatto il suo corso nelle stanze della diplomazia fra l’entusiasmo dei tanti, lo scetticismo dei molti e il fastidio degli altri. Finché, il 29 novembre 2012, l’Assemblea del Palazzo di Vetro ha approvato, a larghissima maggioranza, la risoluzione 67/19 che ha accordato alla Palestina lo status di Stato, nel territorio delimitato dalla Linea Verde, ovvero il confine definito dagli accordi di armistizio tra Israele e Regno di Giordania del 1949. Lo Stato di Palestina è così entrato nella famiglia delle Nazioni Unite, pur rimanendo un fratello minore, un parente acquisito a metà, ovvero uno Stato osservatore e non uno Stato membro a tutti gli effetti. Ciò non toglie che lo storico voto dell’Assemblea abbia espresso un sentire ampio e condiviso nella comunità internazionale - nonostante le poche, prevedibili eccezioni contrarie - e che abbia segnato un passaggio significativo nel percorso di autodeterminazione del popolo palestinese.
Tornando a rivedere le immagini del presidente Abbas che parla sul podio dell’Assemblea, in quel settembre 2011, colpisce che l’esperienza della Palestina abbia registrato movimenti in evidente controtendenza rispetto a quanto accadeva nello stesso periodo a Tunisi, al Cairo, a Tripoli e Bengasi. Può apparire singolare, infatti, che proprio nell’anno delle primavere arabe e delle rivoluzioni dal basso delle piazze verso l’alto dei palazzi del potere, la causa palestinese abbia seguito un percorso inverso, a partire dall’alto degli scranni di New York. Senza riuscire ad approdare, tuttavia, da nessun’altra parte, in particolare nei territori occupati di Gaza e della Cisgiordania. Perché le porte dei check-point che frammentano queste piccole regioni e le ingabbiano nella rete del controllo militare israeliano restano indifferenti a quanto accade altrove, ovunque. La terra e la gente di Palestina continuano a fare i conti, ogni giorno, con un conflitto che rimane irrisolto, prigioniero di ritorsioni e rappresaglie senza soluzione di continuità fra contendenti dalle risorse imparagonabili in termini militari, economici e diplomatici. Nel corso degli anni, i nodi del conflitto sono stati serrati sempre più da una serie di azioni unilaterali che hanno compromesso gravemente ogni possibilità di soluzione.
Nel 2002, dopo il fallimento degli Accordi di Oslo e l’inizio della seconda Intifada palestinese, il governo israeliano ha cominciato la costruzione di un muro di separazione, nel tentativo di dividere con la forza due popoli intrecciati sul territorio in maniera pressoché inestricabile. I cantieri del muro sono ancora aperti: come documenta l’Agenzia delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (UN-OCHA), nell’estate 2013 il muro ha raggiunto la lunghezza di circa 440 km, rispetto ai 712 previsti, e oltre l’80% del tracciato del muro attraversa i territori occupati palestinesi, piuttosto che seguire la linea di confine del 1949, la Linea Verde. Proprio per questa ragione, nel 2004 il muro è stato dichiarato contrario al diritto internazionale dalla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja. Eppure, per quanto autorevole, il parere consultivo dell’Alta Corte rappresenta un altro documento che, ad oggi, non ha prodotto effetti tangibili sul terreno, dove il muro stende i suoi reticolati e i suoi blocchi di cemento a tagliare in pezzi un intero tessuto sociale: studenti da una parte, scuole e università dall’altra; agricoltori, operai, malati, lavoratori, fedeli, e familiari da una parte, campi, ospedali, cliniche, luoghi di culto, posti di lavoro, parenti e cimiteri dall’altra. Quello che conta, spesso, si trova dalla parte sbagliata di un territorio in frantumi. La cesura tra le condizioni de jure e de facto, qui, è profonda: chi non ha la carta d’identità del colore giusto vive la realtà quotidiana di una prigione a cielo aperto. Da oltre quarantacinque anni, in casa propria.
In un contesto simile, documentare la frammentazione che avanza inesorabile diventa necessario. Nell’ottobre 2010, a Firenze, è stato pubblicato un libro fotografico che racconta un viaggio di quasi sei anni lungo il muro di separazione. Oggi l’autore e il curatore di quel libro, dal titolo Un muro non basta, suggerito dalle parole di un graffito apparso nel 2005 sul muro di Betlemme, sono tornati a riflettere su quel muro, in un dialogo fra la Toscana e la costa occidentale degli Stati Uniti.
Andrea Merli – Federico, tu sai che ciò che mi ha spinto a fotografare il muro è il desiderio di conservare la luce che ogni giorno rivelava ai nostri occhi quei blocchi di cemento che andavano a dividere il territorio di Betlemme. Un muro massiccio, imponente, inarrestabile. Eppure, la luce che batteva su questo muro poteva e doveva essere fermata, raccolta, custodita. Era una luce preziosa, che si fermava sul cemento, incapace di raggiungere il terreno, e che raccontava una storia che non poteva essere ignorata. Ho cominciato a camminare lungo questo muro, un passo alla volta, prima a Betlemme, poi a Gerusalemme, poi nel nord della Cisgiordania, a Qalqiliya, a Tulkarem. Dall’autunno 2004 all’estate 2010 ho messo insieme qualche migliaio di scatti. Di questi ne abbiamo scelti insieme un centinaio, quelli che sono pubblicati sul libro. Anche tu, Federico, sei stato in Palestina, hai conosciuto il muro, lo hai visto nascondere l’orizzonte di una terra e privare i suoi abitanti della libertà di movimento. Ecco, partirei da qui. Quando lo hai visto coi tuoi occhi, di un uomo che arriva da fuori, che cosa hai provato?
Federico Busonero - La prima cosa che ho provato guardando il muro dalla macchina che mi portava dall’aeroporto di Tel Aviv a Ramallah è stato un senso di sgomento di fronte all’assurdità di una situazione che andava oltre quello che avrei potuto pensare di vedere, o di immaginare. Il check-point di Qalandiya non identifica soltanto la violenza della separazione di un popolo. E’ un assurdo storico. Come fotografo, l’incarico che mi aveva portato in Palestina richiedeva al mio sguardo di posarsi su altre cose, ma la violenza del muro era ed è dappertutto e non mi ha risparmiato. Il muro mi è rimasto dentro come un’esperienza mia, personale. Non lo guardavo come testimone di una situazione che riguardava altri, abitanti di un paese straniero, ma percepivo fin dallo sguardo una violenza indiscriminata che mi toccava da vicino, che segnava inevitabilmente la mia visione e che raggiungeva la mia coscienza di individuo.
A. – Anche per me è stato così. Ricordo che quando guardavamo le fotografie alla ricerca di un percorso, in certi casi tu hai sentito l’esigenza di usare espressioni particolarmente forti. Per esempio, penso alla fotografia di quel divano che è un relitto, un rifiuto, uno scarto domestico, un luogo d’intimità strappato dal suo contesto e abbandonato sul ciglio della strada 60, all’altezza di Betlemme. Sullo sfondo si vede il muro e tu, davanti a questa immagine, hai detto ‘Questo è uno stupro del paesaggio, questo è lo stupro della Palestina’.
[FIG. 1]
F. – Sì, ho usato questo termine riferito a quell’immagine, che ho ben presente. Quella scena esprime violenza. Sarebbe già una violenza vedere questa scena senza il muro, con quel divano abbandonato lì, fuori posto, fuori luogo. Il muro sullo sfondo, il palo, il divano… Il paesaggio è un bidone della spazzatura e trasmette un senso di abbandono della terra, perché la terra è stata occupata, è stata privata del suo valore intrinseco di appartenenza. La terra di Palestina è stata stuprata sotto tanti aspetti, sotto tante forme. Questa espressione forte, è vero, scaturiva da una visione sconsolata della Palestina che ho avuto viaggiando lungo il muro, ma anche all’interno, verso la valle del Giordano. Tutto questo ha avuto un profondo impatto su di me.
A. - Un’immagine che tu mi hai aiutato a capire è quella che ho scattato senza afferrarne appieno il significato, sul momento. E’ l’immagine di quell’incrocio sulla strada 443 dove si vedono un semaforo, dei segnali stradali, una torre militare, in un quadro di periferia urbana quasi indifferente. Potremmo essere all’esterno di un carcere di massima sicurezza. E in effetti lo siamo, anche se la percezione non è chiara, ma è confusa, resa incerta da elementi che sembrano appartenere a un contesto del tutto ordinario. Di fronte a questa immagine, hai messo in evidenza il concetto di nonluogo.
[FIG. 2]
F. – Vedi, questo incrocio l’ho attraversato per la prima volta di notte, quando arrivai in Palestina, e non capivo dove mi trovavo, cosa fosse. Poi ci sono ripassato diverse volte. Questa è la fotografia che io avrei fatto, se tu non l’avessi già fatta. Mi hai portato dentro una situazione fisica e mentale che per me era già lì. Per me questa è una fotografia importante non solo perché si vede il muro: se non fosse per quello, potremmo essere altrove, ovunque. Ecco perché ho parlato di nonluogo, riprendendo un concetto dell’antropologo Marc Augé (2009). I nonluoghi sono luoghi di transizione, di passaggio, di collegamento dal punto A al punto B, luoghi che attraversiamo, luoghi che non sono mai destinazioni, luoghi che sono sempre mezzi e mai fini in sé. Nella fotografia c’è una freccia blu sopra il semaforo che indica verso il cielo, mentre da un’altra parte c’è una freccia che mi dice che non posso andare a destra. C’è una cacofonia di simboli quasi astratta rispetto al luogo geografico in cui siamo. La fotografia ci parla dell’ambiguità di un luogo e l’ho associata alla fotografia degli incroci fotografati da Friedlander per esprimere la solitudine del paesaggio americano. I semafori, i segnali stradali… C’è un senso di spaesamento, di disagio, come se ci trovassimo in un luogo che è uguale a tanti altri luoghi. In realtà non lo è perché c’è il muro con la bandiera israeliana che lo identifica. Ma se tu lo rimuovi, potremmo essere ovunque. E poi, in questa immagine c’è un’altra cosa che mi ha colpito: è paradossale che io passi accanto al muro senza rendermene conto. La prima volta pensavo che fosse una prigione, appunto, un carcere. Poi, ho capito che era un’altra cosa. Non molto diversa, in effetti, ma un’altra cosa. Ecco la difficoltà di leggere il paesaggio in luoghi che fanno fatica a trovare una loro identità.
A. – Oppure, potremmo dire, la difficoltà di conoscere luoghi che non riescono a comunicare la loro identità per timore di riconoscerla, per timore di guardare il proprio riflesso. In questo ovunque non c’è nulla, se non semafori e cartelli che ci dicono la direzione che dobbiamo o non dobbiamo prendere. Indicazioni. Divieti. Muri. Regole. Sensi unici. Un ordine sterile e immaginario che fa a pugni col disordine del reale. Un ordine che, in questo caso, evoca il silenzio dell’oppressione, non l’esuberanza della libertà. Vorrei rivedere anche l’immagine del quartiere di Abu Dis, a Gerusalemme Est, dove una donna palestinese vestita pesante da capo ai piedi, secondo la tradizione islamica, cammina in avanti, allontanandosi dal punto di osservazione. Sulla destra si vede un bambino che corre in bicicletta verso non si sa dove, davanti a un graffito ricco di segni. Si vede un’arma, una scritta, uno stemma politico. Poi c’è il muro che chiude l’orizzonte. Questa è un’immagine abbastanza complessa perché è fatta di tanti elementi, densa di simboli. A differenza di prima, nel momento in cui ho scattato questa fotografia ho avuto la consapevolezza di cogliere una scena non soltanto descrittiva, ma anche evocativa di qualcosa di più, una scena che non ci mostra soltanto un momento, un istante, uno spazio, un luogo ben preciso con le sue coordinate spazio-temporali, ma una scena evocativa, appunto, di una condizione esistenziale.
[FIG. 3]
F. - Quello che dici è interessante. L’immagine di cui si parlava prima, quella dei segnali stradali, è opposta a questa. Intanto, lì eravamo all’esterno del muro, si passava attraverso un nonluogo senza renderci conto del contesto per quello che era. Qui, invece, siamo dentro, all’interno del muro. Questo è il compito del fotografo che deve andare oltre il visibile, oltre la superficie delle cose. E qui hai colto una sintesi non solo del luogo, ma anche della disperazione di questo luogo. La fotografia è perfettamente bilanciata. Ci sono tre elementi che attirano il mio sguardo: sulla sinistra c’è la donna che è schiacciata da questa situazione e va verso il muro, verso il suo destino. Anche il ragazzo va in una direzione che non sappiamo quale sia, anche lui è chiuso come lo è la donna, ma vanno in direzioni opposte. E qui potremmo anche leggere una cesura, una sorta di incomunicabilità tra generazioni diverse, eppure prigioniere allo stesso modo. Poi c’è questa porta, che ancora ci dà un’idea di chiusura, e ci sono i segni sul muro di una casa, il mitra, una scritta. Qui vediamo che un muro domestico, inoffensivo, anzi, protettivo, si tinge di simboli di resistenza e anche di violenza. Ma perché? L’immagine ce lo mostra il perché: c’è un altro muro sullo sfondo, ben più grande e minaccioso. In questa fotografia dove si vedono due persone che si muovono c’è il dramma di un’intera popolazione che è stata privata della sua libertà di movimento. Di nuovo, ecco perché questa fotografia è opposta all’altra, dove si vedono ampi spazi per il movimento, le strade, ma non c’è nessuno che si muove. Le due fotografie, messe accanto, esprimono la condizione fuori/dentro.
A. – In effetti, vale la pena di tornare su questo punto: il problema fondamentale della Palestina riguarda la privazione della libertà di movimento - sulla propria terra, dalla propria terra e verso la propria terra - e la privazione dell’utilizzo delle proprie risorse, anche in termini di semplice spazio. Ciò che comporta l’occupazione militare e civile in atto dal 1967 è vivere in un ambiente di reclusione forzata. Che è il carattere distintivo, identitario, di una prigione. Naturalmente esistono questioni economiche e sociali importantissime, in Palestina, ma la privazione della libertà di muoversi e di agire rimane il primo nodo da sciogliere per affrontare quelli successivi. Questa immagine parla di un mondo chiuso, mostra movimenti senza una destinazione precisa, racconta un luogo che sembra una gabbia da laboratorio, dove esistono percorsi obbligati che in fondo sono soltanto dei vicoli ciechi. Uno scenario di questo genere può essere accostato al concetto di eterotopia elaborato da Foucault, in quanto spazio reale che non si esaurisce in sé stesso, ma che rimanda ad altri luoghi e che assume molteplici livelli di significato. Nel caso palestinese, il significato dipende dall’identità di chi si trova nei territori occupati che rimangono a est del muro, dove i permessi di accesso e circolazione sono regolati da un regime estremamente complesso. Le aree urbane e semi-urbane, classificate nelle categorie A e B dagli accordi di Oslo del 1994, sono spazi di residenza e di reclusione per i cittadini palestinesi della Cisgiordania, spazi generalmente interdetti ai cittadini israeliani, e spazi di accesso relativamente libero per i visitatori internazionali muniti di visto israeliano sul passaporto. Le zone classificate nella categoria C, che corrispondono a quasi due terzi della Cisgiordania, sono sostanzialmente spazi di transito per i cittadini palestinesi, che non possono sviluppare il territorio in alcun modo attraverso la costruzione di infrastrutture civili, rurali e commerciali, e allo stesso tempo sono spazi di espansione per le colonie israeliane diffuse a macchia di leopardo. Lo stesso identico territorio assume significati profondamente diversi: da prigione a terra dei pionieri. Del resto, sia la prigione che la terra da colonizzare sono modelli di eterotopia esplicitamente suggeriti da Foucault. Credo che il riferimento alla prigione possa essere utile per mettere in evidenza alcuni tratti del contesto e dell’esperienza palestinese. Allo stesso tempo, però, mi sembra essenziale non perdere di vista il fatto che qui, a fronte di una condanna in esecuzione da oltre quattro decenni, non esiste una colpa che si possa addebitare ai reclusi, se non quella di vivere in casa propria. Lungi dall’essere una struttura che partecipa all’affermazione della giustizia e alla riabilitazione di un determinato contesto sociale, la prigione palestinese dimostra una desolante, drammatica assenza di giustizia, di fronte all’intera comunità internazionale. Ma torniamo alle immagini, Federico. Aprendo il libro in questo momento, a qualche anno di distanza dalla pubblicazione, c’è un’immagine che ti colpisce, che ti attira, che trovi ancora attuale, magari di cui abbiamo parlato poco?
F. - La forza del libro è di aver colto la complessità della situazione sociale, economica e geografica nello spazio e nel tempo, scandita nella progressione di questo muro. Per esempio, un’immagine che porto dentro di me è quella della coppia che cammina verso il check-point di Qalandiya. Qui non c’è solo il muro, ma si vede un contesto sociale in cui l’uomo cammina qualche metro avanti alla donna, che segue dietro: è una scena che apre tutto un discorso sulla società palestinese rinchiusa in questo muro. Così come l’immagine successiva, in cui la costruzione fisica del muro contrasta fortemente con le piccole figure di cinque persone che camminano a piedi e che diventano quasi delle silhouettes, a qualche distanza l’una dall’altra. Se rimuovi le persone, questa diventa una semplice fotografia di documentazione. Ma le persone aumentano il carico espressivo dell’immagine nel momento in cui esprimono lo schiacciamento dell’individuo. Le persone ci sono, ma spariscono, vengono chiuse, murate dentro. Direi che queste due immagini sono complementari. La prima ci fa capire che esiste una società palestinese, coi suoi problemi e le sue questioni sociali e culturali, certo, ma è una società che esiste, tutt’altro che immaginaria. Qui, nella seconda fotografia, la società sparisce. Si vedono solo persone distanti, in fila, schiacciate. La società non si vede più, scompare. Questa fotografia non è solo un documento del muro, ma di una società che viene scardinata, frammentata, polverizzata dal muro.
[FIG. 4]
[FIG. 5]
A. - Secondo te, qual è il ruolo del fotografo in un contesto come questo? Che cosa deve fare, che cosa può fare, che cosa ci si deve aspettare da un fotografo? E’ sufficiente fotografare? Il fotografo è qualcosa di più di una figura che ferma la luce, la raccoglie e la mette da parte, non è vero?
F. - Non c’è una risposta univoca. Non è solo cercare la luce che mette in evidenza quello che ci sta davanti. Il fotografo rappresenta, o dovrebbe cercare di rappresentare, la cattiva coscienza del mondo. Perché si interroga su quello che ha davanti. E su quello che noi facciamo qui, in questo momento. Questo è il suo ruolo, se si può parlare di una fotografia che costruisce una realtà. Come fotografi del reale ci assumiamo una responsabilità enorme. Ho parlato di coscienza perché la fotografia implica necessariamente una scelta etica. Questa è la forza del fotografo, il dovere e anche la solitudine del fotografo. In effetti, credo che sia un viaggio molto solitario, quello del fotografo, che diventa un testimone scomodo. Questo tipo di lavoro può essere fatto in molti modi, anche attraverso la fotografia. Da queste fotografie si vede che il dolore dell’altro è diventato, in qualche modo, anche il tuo dolore.
A. - Condivido quello che dici, per quanto sia complicato metterlo in pratica. Il fotografo non è un collezionista di luci, come se fossero farfalle. E’ un soggetto pensante, inserito in un contesto, che compie una serie di scelte, non solo tecniche ma innanzitutto etiche. Sono scelte difficili che comportano responsabilità, ma anche solitudine, è vero. Un’altra cosa che mi chiedo è questa. Si può parlare, secondo te, di un’estetica del muro? Come sfuggire alla trappola di celebrarlo, questo muro, cedendo involontariamente al fascino del maledetto? Come evitare di fare il gioco del muro nel momento in cui lo si colloca al centro di un progetto fotografico? Il muro non corre il rischio di diventare un soggetto di studio per l’appagamento intellettuale di osservatori che arrivano da fuori, col loro bel passaporto, senza le restrizioni di movimento che vincolano gli abitanti? In questi luoghi un osservatore occidentale ha il privilegio di passare abbastanza agevolmente da un lato all’altro del muro. Mi rendo conto che sono domande scomode, spinose, ma non possiamo trascurarle.
F. - Sai, ci sono due piani su cui credo di poter affrontare questa domanda. Uno è esclusivamente fotografico, mentre l’altro è più tecnico e riguarda il lavoro documentario portato avanti dalle agenzie delle Nazioni Unite, per esempio. Quello che accade sul terreno viene descritto nei loro rapporti in modo molto preciso, forense, analitico, come è giusto e doveroso che sia. Dall’altra parte c’è il lavoro del fotografo. Il rischio che il muro offra la sponda a una sorta di compiacimento estetico, se vogliamo chiamarlo così, c’è. Ma credo che sia un rischio trascurabile, o quantomeno accettabile, vista l’enormità della situazione che stiamo affrontando. La Palestina è un luogo fortemente simbolico. Il conflitto è una ferita aperta. Il rischio di estetizzare la violenza esiste in Palestina, in un contesto che ha una potenza visuale e concettuale fortissima, ma non solo in Palestina. Non è facile esserci, non è facile fotografarlo e nemmeno parlarne, però dobbiamo farlo. Io non vedo in queste fotografie un compiacimento di tipo intellettuale. In altri casi ci possono essere situazioni dove si può trarre un vantaggio da una situazione così potente. E comunque, è un rischio che dobbiamo correre.
A. – Penso che valga la pena correre questo rischio se l’immagine arriva a toccarti, a porre una domanda, a interrogarti. Un osservatore può accostarsi a un’immagine sulla base di considerazioni molto varie, anche a partire dal fatto che può essere esteticamente interessante. E’ un rischio che vale la pena affrontare nel momento in cui la fotografia crea un incentivo a considerare un problema, a considerare un contesto che altrimenti resterebbe al di fuori delle nostre percezioni, del nostro spazio mentale. Credo che il rischio dell’estetica del muro sia una declinazione dell’estetica del dramma che si presenta in tanti contesti del mondo: guerre, carestie, epidemie, stragi, calamità naturali. Prigioni. C’è un’estetica di fronte a tutto questo che esercita un’attrazione su di noi, non possiamo ignorarla. E’ un terreno molto, molto scivoloso quello su cui si muove il fotografo che decide di affrontare questo genere di soggetto. Però, alla fine, l’immagine fa il suo lavoro quando arriva a posarsi davanti agli occhi di qualcuno e a consegnare la sua domanda.
F. - Andrea, questo mi porta a un’altra osservazione. Ogni immagine che noi facciamo suscita a livello del cosciente un’esperienza estetica. Come ha detto Susan Sontag, le fotografie tendono per loro stessa natura a rendere le cose più belle di quello che sono, oppure più brutte di quello che sono. Proprio perché sono frammenti di realtà che isolano una parte dal tutto...
A. - ... come se fossero conchiglie colorate, pezzi di vetro o lattine abbandonate su una spiaggia di sabbia grigia...
F. - ... ma i soggetti delle fotografie possono anche essere pezzi di spiaggia grigia, solo che in quel caso non ti accorgeresti delle parti colorate. E allora potresti pensare, sbagliando, che la spiaggia è tutta grigia. Il punto è che il tutto è sempre più grande di noi e di quello che vediamo. Prendiamo la tua immagine del muro che sale a serpentina. E’ un’immagine ben composta, quasi astratta, in cui si vede il muro che circonda un albero, poi continua la corsa lungo la collina. Di primo acchito, si può dire che questa è una bella fotografia, ben composta. Hai voluto far vedere la forma del muro, che è una forma geometrica, precisa. Questa è un’immagine, si potrebbe dire, che tende a estetizzare il muro. Anche un muro orrendo come questo, qui assume una forma astratta, pulita. Una persona che guardasse solo questa immagine, potrebbe non percepire il dramma. Ma c’è un paesaggio che viene distrutto dall’avanzata di questo muro, intorno a questo frammento di realtà c’è altro. E il progetto ce lo mostra. Una persona che guardasse soltanto questa immagine potrebbe apprezzarne l’ordine estetico, in superficie. Però, intanto, si avvicinerebbe al contesto, sfoglierebbe il libro, conoscerebbe il progetto e vedrebbe anche altro. C’è un punto essenziale: questa fotografia non viene proposta da sola, isolata, ma fa parte di un percorso approfondito attraverso un contesto complesso. A livello di progetto, tu non hai certamente voluto mettere in evidenza il muro come oggetto architettonico. Ancora, prendi quest’altra immagine con una strada deserta tra due muri, asettica. Anche qui si potrebbe porre lo stesso problema, anche questa potrebbe sembrare una bella immagine, al limite dell’astratto, quasi artificiale. Ma attenzione, c’è un altro elemento che è parte integrante del lavoro e che non si può trascurare: la didascalia, che ci dice che siamo a Betlemme. Mi segui? E allora viene immediatamente un senso di angoscia. Caspita, questa è Betlemme? Dov’è Betlemme? Betlemme non c’è più, non c’è traccia di vita, si vedono soltanto cielo, cemento e asfalto. Come dalla finestra di un carcere, manca ogni riferimento. Eppure, questo non è un carcere, questa è una città. Tu lo dici. E, in questo modo, riporti l’immagine al suo posto, la ancori al suo terreno, al suo luogo, frenando la fuga estetica di colui che guarda. Detto questo, ci stiamo ponendo delle domande coraggiose, non facili, proprio perché stiamo facendo i conti con l’ambiguità e coi limiti della fotografia e dell’animo umano. Dobbiamo essere consapevoli di questi limiti, come dire, naturali. La fotografia non pretende di esaurire il reale, non sostituisce l’esperienza diretta di un luogo e non appartiene solo al fotografo, ma anche a chi la guarda.
[FIG. 6]
[FIG. 7]
A. – Sì, credo che sia importante che questo muro venga visto soprattutto da chi non lo conosce, da chi potrebbe non fare attenzione a immagini più crude per assuefazione, timore o fastidio. Allora diventa importante che l’osservatore sia disposto a fare un percorso, ad abbandonare la pretesa di tirare conclusioni affrettate a partire da un’occhiata superficiale e a mettere insieme un quadro che vada oltre la singola impressione. Inoltre, potremmo dire che in questo tipo di immagini il demone c’è ma non si vede, nascosto dietro l’apparenza di un ordine estetico che può risultare paradossalmente piacevole. Proprio come accade spesso nella realtà. Allora, l’immagine rimane autentica e fedele nel suo rapporto col reale per quello che nasconde, piuttosto che per quanto ci mostra, e richiede partecipazione nel tentativo di decifrare il soggetto, senza pretendere di rivelarlo da sola per quello che è.
F. - Andrea, è importante ritornare sulle immagini non solo perché esse sono parte della nostra biografia ma soprattutto perché, con il passare del tempo, acquistano un’autonomia propria, si distaccano dal loro hic et nunc e si aprono ad altre considerazioni e associazioni di pensieri che potremmo non aver colto allora nella loro interezza. Condivido pienamente Susan Sontag quando, nel suo libro Regarding the Pain of Others (2003), scrive che le fotografie ci incalzano, ci perseguitano, non ci lasciano. Photographs hunt us. Esse rimangono con noi e condizionano il nostro modo di guardare le cose e noi stessi. Perché ogni fotografia è al tempo stesso un documento e un’immagine – un documento di ciò che si trova di fronte ai nostri occhi nella brevità dell’istante dello scatto, e un’immagine, un’apparizione del e dal visibile, creata dal fotografo. Se ci pensi bene, succede che noi ricordiamo non tanto un fatto, una cosa, una persona mediante una fotografia, quanto la fotografia stessa, cioè l’immagine che abita il nostro subconscio. Vorrei commentare con te due mie fotografie che si ricollegano a quanto abbiamo detto nel guardare le tue immagini del muro.
[FIG. 8]
Questa fotografia, come ti dicevo, non mi lascia. Continuo a pensarci anche quando non l’ho davanti. Non so cosa sia accaduto a quel neonato di pochi giorni che avevo trovato sul lettino di un ambulatorio nel villaggio di Azzun Atma, che tu conosci, uno dei tanti villaggi palestinesi chiusi e prigionieri del muro e dei check-point israeliani. Potei passare il posto di blocco ed entrare ad Azzun Atma, quel mattino dell’agosto 2009, solo perché avevo un lasciapassare dell’OMS, l’agenzia delle Nazioni Unite per la quale fotografavo allora. La fotografia ci parla di una condizione fragile, di un presente difficile. Si vedono un otoscopio e un neonato indifeso che prende la forma della coperta bianca che lo avvolge, come a proteggerlo dal muro sporco e graffiato. Nella fotografia rimane sospesa l’ineluttabile solitudine della condizione di un neonato del quale possiamo soltanto immaginare il destino. Nel rapporto The Right to Health in the occupied Palestinian territory: West Bank and East Jerusalem l’OMS mise questa fotografia accanto alle statistiche sul tasso di mortalità infantile in Palestina. Come vedi, la fotografia è un documento e, al tempo stesso, un’immagine che va oltre il documento perché ci conduce a un livello più profondo di consapevolezza e di partecipazione. La presenza del muro impedisce il libero movimento della popolazione e quindi l’accesso a cure sanitarie adeguate. Il neonato di Azzun Atma, avvolto in una coperta dinanzi a un muro sporco e graffiato, è venuto al mondo in quella che, di fatto, è una prigione.
A. – La condizione della solitudine imposta dalla frammentazione del territorio si coglie anche nella straordinaria immagine del cavallo lungo la strada per il villaggio di Iskaka, un ambiente completamente diverso dalla clinica, eppure appartenente allo stesso mondo, osservato con gli stessi occhi. Il muro di separazione non si vede, ma c’è qualcosa che mi spinge ad accostare questa immagine a quella che abbiamo visto prima, con la donna e il bambino in bicicletta. Il cavallo è immobile, legato al palo, rivolto verso il muro grezzo di un’abitazione. Sta fermo ai margini della strada, nell’impossibilità di percorrerla, di svoltare la curva e andare oltre. Il cavallo appare robusto e vigoroso, ma senza la possibilità di correre trasmette la sensazione di una creatura incompiuta, come i pilastri di cemento sulla sinistra. Di nuovo è presente la dimensione della prigionia, dell’immobilismo forzato, di un’attesa vacua. L’inquadratura coglie un contesto molto più ampio e complesso del frammento di realtà che sta davanti all’obiettivo.
[FIG. 9]
F. - Questa fotografia mi è particolarmente cara. Ci sono immagini che, rispetto ad altre, mi toccano e mi prendono ad un punto tale che non so bene farmene una ragione. Come se le parole venissero all’improvviso a mancare. La fotografia è semplice da descrivere: un edificio non completato, una strada, un cavallo legato a un palo, una casa alla sua destra della quale si intravede una porta verde, chiusa. Ebbene, è proprio l’insieme di questi elementi che disorienta l’osservatore: la strada sembra non condurre in nessun luogo, ogni cosa, animata e non, rimane immobile, scolpita nell’istante della fotografia. Tu ed io sappiamo bene che quella strada conduce, dopo pochi chilometri, al posto di blocco di Tappuah, sulla Route 60. La fotografia è un simulacro, l’effige di una condizione drammatica. Qui non c’è il muro che chiude fisicamente e visivamente l’accesso e che impedisce di andare oltre. Eppure è come se ci fosse, invisibile e per questo ancor più terribile. Osserviamo la distruzione della terra e ne sentiamo il dolore. Ciò che vediamo nell’immagine-documento è un luogo privato della sua geografia e avulso dal suo stesso presente – il territorio Palestinese occupato.
BIBLIOGRAFIAAUGÉ M. (2009), Nonluoghi, Elèuthera, Milano.
International Court of Justice (2004), Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory. www.icj-cij.org/docket/?p1=3&p2=4&k=5a&case=131&code=mwp&p3=4 , visionato il 26/07/2013.FOUCAULT M. (1984), “Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias”, in Architecture /Mouvement/ Continuité, October 1984 (Titolo originale: “Des Espace Autres”). http://web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf, visionato il 04/08/2013.
MERLI A. (2010), Un muro non basta, Edizioni della Meridiana, Firenze. www.yoxphoto.com/muro, visionato il 04/08/2013.
SONTAG S. (2003), Regarding the Pain of Others, Farrar, Straus and Giroux, New York.
UN-OCHA (2013), The Humanitarian Impact of the Barrier, Gerusalemme. www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_factsheet_july_2013_english.pdf , visionato il 04/08/2013.
WHO oPt Office (2009), The Right to Health in the occupied Palestinian territory: West Bank and East Jerusalem - August 2009, Gerusalemme.
http://info.publicintelligence.net/WHOpalestinehealthreport.pdf , visionato il 04/08/2013.

Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Elephant & Castle

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.