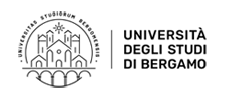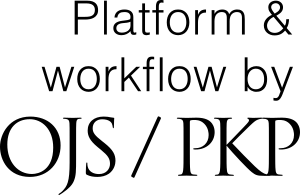Editoriale
Abstract
È possibile individuare un elemento costante, un procedimento comune – che vada al di là dei temi e dei contenuti condivisi – nel percorso creativo di quegli artisti che hanno saputo esprimersi attraverso mezzi diversi? Quali strumenti utilizzare per analizzare e interpretare opere che dispiegano il loro potenziale semiotico attraverso codici espressivi differenti? È possibile ipotizzare un canone contemporaneo che attribuisca un posto di rilievo, e non solo eccentrico, alle esperienze intermediali?
Da questi interrogativi ha preso le mosse il presente numero di Elephant&Castle dedicato alle prospettive transmediali per lo studio della letteratura. In un’epoca come la nostra, caratterizzata da una predominanza sempre più evidente del visivo rispetto agli altri paradigmi espressivi – si pensi alla comunicazione pubblicitaria, al cinema, ma soprattutto all’inesausta proliferazione semantica del web –, un momento di interrogazione critica, teorica e metodologica circa le strategie attraverso cui la meno visuale delle discipline, la letteratura, ha nel corso degli ultimi decenni intessuto un dialogo con le arti visive appariva doveroso. Il punto di osservazione prescelto per questa indagine – che va ad affiancarsi ai tanti studi e ai tanti “luoghi” di ricerca che in quest’ambito lavorano da anni, in Italia e all’estero – è stato quello dei cosiddetti Doppelbegabungen, ovvero gli artisti abituati a esprimere il proprio talento creativo attraverso differenti media che fanno riferimento a codici verbali e visuali.
«Le idee bisogna considerarle come dei potenziali già impegnati in questo o in quel modo d’espressione e inseparabili dal modo d’espressione»: così scriveva Gilles Deleuze in Cos’è l’atto di creazione (1986), dando nuova linfa alle posizioni che in origine furono espresse da G. E. Lessing nel celebre saggio sul Laocoonte. In tempi di multimedialità congenita sembra davvero anacronistico insistere ancora sulla separazione tra arti della parola e arti dell’immagine, e il lavoro di artisti dalla “doppia ispirazione” sta a dimostrare come invece sia più opportuno individuare le fasi in cui avviene uno scambio tra i codici e le rispettive istanze formali si intrecciano secondo un’intenzione espressiva nuova.
I rischi insiti in questo approccio interpretativo sono tanti e sono ben sintetizzati nelle parole di Ulrich Weisstein, citate qui da Mariaelisa Dimino. Weisstein è uno studioso d’area germanica che fin dagli anni Sessanta si è cimentato nel campo delle relazioni intermediali, dove ha finito per notare che «nel sollevare la questione del talento multiplo […] stiamo abbandonando il regno sicuro degli oggetti tangibili e delle loro relazioni strutturali per entrare nel dominio precario della psicologia» (Literature and the Visual Arts, 1982). Non è un caso infatti che, soprattutto negli ultimi dieci anni, le scienze cognitive abbiano costituito un nuovo orizzonte di riferimento per quegli studi che intendevano estendere alla dimensione dell’ispirazione e della “creazione originaria” l’analisi della composizione artistica. Lo stesso call for papers di questo numero prendeva le mosse da suggestioni derivanti dalle prospettive aperte da una convergenza tra critica, letteratura e scienze cognitive, per come sono praticate oggi da alcuni settori della ricerca italiana. Tuttavia, se nel caso di quella che vorrebbe essere una scienza esatta, come la narratologia, l’approccio cognitivo permette di aprire a un nuovo terreno di studio un sistema concettuale già compiutamente formalizzato da decenni di indagini strutturaliste, nel caso dello studio dei processi creativi – e per di più intermediali –, il contributo delle scienze della mente rischia di annebbiare i confini di una ricerca di per sé già complessa, che non ha ancora individuato i propri specifici strumenti di lavoro.
Ne sono una dimostrazione empirica gli otto contributi raccolti in questo numero di Elephant&Castle, che rifuggono l’approccio cognitivo per provare invece a interrogare tradizionali metodi critici alla luce delle nuove istanze della dimensione intermediale: il risultato è eccellente e mostra perfettamente come sia possibile rimodellare le capacità interpretative di metodi critici apparentemente invecchiati sottoponendoli alle necessità di un’analisi relazionale e integrata dei rapporti tra arti visive e scrittura.
Si prenda il testo di apertura, l’unico di carattere prettamente teorico. Lorenzo Cardilli utilizza il repertorio di strumenti della stilistica e della semiotica per stilare una schematica tassonomia dei meccanismi figurali attraverso cui la parola poetica costruisce l’«immagine verbale». Partendo dal presupposto che l’immagine è un costituente primario dei processi di significazione della poesia (e non solo di quella di esplicita ispirazione visuale), l’approccio metodologico adottato ribadisce la centralità del testo scritto – al di là dei rinnovati equilibri stabiliti dal pictorial turn – e mette in risalto la capacità della parola poetica di integrare media diversi nella sua opera di costruzione di mondi.
La sezione di studi monografici che costituisce il corpo di questo numero conferma la difficoltà di varare approcci critici che richiedano competenze ancora molto distanti tra loro (stilistico-narratologiche e psicologico-cognitive) e ribadisce come la close reading rimanga, oltre che un porto sicuro degli studi letterari, anche un fecondo (perché circoscritto) porto di partenza per un inedito viaggio attraverso i media. Mariaelisa Dimino ricorre alla filologia per studiare l’unico romanzo pubblicato dal disegnatore austriaco Alfred Kubin (1877-1959), L’altra parte. Un romanzo fantastico (1909), capolavoro di genere nella tradizione di lingua tedesca. La consultazione della biblioteca personale, il lavoro sui taccuini di schizzi e sui manoscritti e il confronto puntuale delle diverse stesure permettono all’autrice di ancorare a un concreto progetto creativo quell’astratto concetto di «visione» che presiede alla doppia creazione di Kubin. L’estetica e la critica stilistica sono gli strumenti adoperati da Silvia Baroni nel suo studio dedicato al rapporto tra scrittura e disegno nell’opera di un altro protagonista d’inizio Novecento, Jean Cocteau. Artista ubiquo, che “costeggia” ogni forma espressiva senza mai affidarle la definizione della propria identità, Cocteau è l’incarnazione dell’artista che sfugge a qualsiasi tentativo interpretativo che voglia provare a includerne la totalità dei volti. Eppure, un’indagine condotta sulle contraddittorie prese di posizione circa la grammatica dei diversi gesti creativi, messa a reazione con uno studio del romanzo Les enfants terribles quale campo di massima tensione delle sue sperimentazioni verbali e visive, permette di arrivare a plausibili conclusioni sulle gerarchie poetiche stabilite da Cocteau e sulla considerazione della linea quale termine estetico capace di incardinare tra di loro tutte le forme espressive.
Mattia Mossali, invece, prende le mosse dalla lunga tradizione di studi sull’ekphrasis, oltre che dal ricco bagaglio della psicanalisi lacaniana, per indagare l’origine dell’immaginario di Sylvia Plath, la cui poesia nasce da un’immaginazione pienamente visuale, intimamente legata a un’urgenza confessionale da sempre riconosciuta dalla critica. Proprio questo profondo rapporto tra ispirazione creativa ed esperienza biografica porta Plath prima a cercare una scrittura che mimi la capacità dei grandi «artisti primitivi» di dare espressione formale a una violenta intensità emotiva, e poi, anche a causa dell’avanzare della sua depressione, a tradurre verbalmente i contenuti di un Reale psichico che si presenta al di fuori del linguaggio, sotto forma di immagini. Alle numerose ricerche nel campo delle teorie dell’adattamento – e agli interessanti studi di Francesco Casetti e Paola Scrolavezza – si rifà invece Stefano Locati, il cui articolo si concentra sulle esperienze di Murakami Ryū e Iwai Shunji, due romanzieri giapponesi che si sono cimentati nella trasposizione cinematografica delle loro stesse opere. Il mercato giapponese dell’intrattenimento è estremamente fecondo di simili esperimenti, ma i casi di Murakami e Iwai risultano particolarmente significativi perché la distanza temporale che li separa permette di osservare come nel corso degli anni si siano trasformate le modalità dell’adattamento: dai compromessi stilistici e semantici che comporta la trasposizione di una sintassi verbale statica in una verbo-visuale dinamica si passa, all’inizio del nuovo millennio, al tentativo di sfruttare tutte le potenzialità narrative del testo attraverso la sua proliferazione su ulteriori piattaforme mediali – specialmente online – da affiancare alla “semplice” traduzione per il grande schermo.
Gli ultimi interventi infine sono dedicati non solo ad artisti dalla doppia ispirazione, ma anche a opere propriamente multimediali; opere in cui scrittura e immagine cooperano alla costruzione di uno spazio semantico ed estetico nuovo. È il caso di L’image fantôme di Hervé Guibert e di L’usage de la photo di Annie Ernaux di cui si occupa Mariarosa Loddo. In queste due opere, la scrittura autobiografica (e autofinzionale nel caso di Guibert) convoca la fotografia quale strumento necessario per potenziare il processo di scomparsa dell’io che la narrazione verbale intraprende. Che l’intenzione finale sia di contribuire con la propria biografia a una storia sociale del paese oppure di dare vita a un processo interiore che passi in rassegna ossessioni e fantasie intime, sia Ernaux che Guibert, sulla scorta del Barthes della Camera chiara, affidano ai vuoti e ai profili rievocati dalle immagini fotografiche il compito di rendere visibile una tensione verso la morte che i corpi già manifestano (nel caso di Guibert a causa dell’AIDS, in quello di Ernaux per un cancro poi sconfitto).
A tutt’altro registro dell’interazione fra visivo e verbale fa riferimento l’esperienza della poesia concreta del gruppo poetico brasiliano Noigandres, affrontata da Luca Romani con alcuni degli strumenti messi a disposizione dalle ricerche dei Sound Studies. Solo un approccio relazionale e aperto, che sappia includere nell’analisi del testo anche l’elemento acustico, può interpretare nella loro complessità i «poemi immagine» di Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Decio Pignatari, che non sono riducibili alle semplici sperimentazioni tipografiche generalmente attribuite alla poesia concreta, e che anzi trovano nell’originale concetto di verbicovisual il modo di riassumere un’eredità teorica tratta dalle avanguardie storiche nei diversi campi espressivi (Apollinaire, Mondrian, Webern). E al campo della pittura afferisce un’altra esperienza multimediale come quella di Roberto Longhi, critico e storico dell’arte che, pur non essendo l’autore delle fotografie che illustrano i suoi testi, dev’essere considerato l’unico artefice dell’accurato lavoro di "ipertraduzione" che attraverso soluzioni retoriche studiate finisce per amplificare attraverso le immagini fotografiche la narrazione del dipinto rappresentato. Il contributo di Martina Massarente indaga la disposizione relazionale della scrittura di Longhi, che si pone come tertium di un processo creativo che prende spunto dalla visione dal vivo dell’opera d’arte e si realizza poi concretamente in compresenza della sua riproduzione fotografica. Scopo finale del testo non è la semplice ricostruzione “ornata” dei caratteri di un’opera d’arte, ma talvolta anche l’avanzamento di un’ipotesi attribuzionistica che il rapporto immagine-testo riesce a giustificare.
Non basteranno senz’altro questi otto contributi a modificare le strategie della ricerca letteraria, né saranno sufficienti ad attivare nuovi e più originali criteri di canonizzazione, aggiornati alle potenzialità di una dimensione intermediale dell’espressione artistica. Sicuramente, però, la varietà degli approcci critici adottati e la disparata provenienza – geografica e cronologica – delle opere studiate in questa sede servirà ad ampliare gli orizzonti degli studi umanistici, promuovendo una ricerca che sappia integrare in maniera sempre più efficace le diverse tradizioni critiche e metodologiche.
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza
Copyright (c) 2023 Elephant & Castle

TQuesto lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.