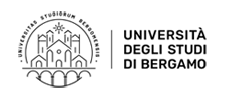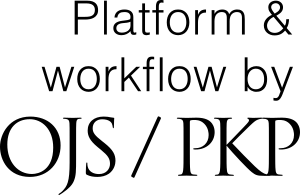La rappresentazione del carcere nel cinema di Kim Ki-duk
Abstract
Qualora si decida di imbastire un discorso di qualsiasi genere intorno all’istituzione carceraria che la consideri non tanto come un’entità fisica o reale, ma nella sua più generica accezione ideale, non si potrebbe non prendere le mosse dal fortunatissimo Sorvegliare e punire di Michel Foucault. L’opera, divenuta ormai (e a ragione) un vero e proprio classico, traccia una disamina dell’evoluzione dei poteri disciplinari e delle forme di esercizio di questi stessi poteri all’interno della società. Il potere disciplinare, dice sempre Foucault, si distingue fortemente dal potere sovrano perché a differenza di quest’ultimo ha la insopprimibile necessità di conoscere gli individui su cui si esercita; proprio in conseguenza di questa sua vocazione ontologica esso ha favorito il sorgere di nuove discipline (le cosiddette scienze umane), che fa germinare e da cui è al contempo rafforzato.
L’opera di Foucault è stata di fortissima ispirazione per molti artisti che, nel tratteggiare solitamente universi distopici, hanno messo in pratica gli insegnamenti del filosofo francese. Forse l’esempio più efficace può essere quello – anacronistico – di 1984 in cui campeggia il celeberrimo slogan sull’onnipresenza del Grande Fratello. Big Brother is watching you: in ogni istante ogni individuo è posto potenzialmente sotto il controllo di un’istituzione disciplinare che può, a sua discrezione, sapere tutto senza che lo spiato si accorga di essere tale. Questo voyeurismo perfetto [1] si concretizza nel terrore paranoide dei sottoposti, schiacciati da una possibilità della cui effettiva realizzazione non vengono mai informati.
Il cinema ha avuto una grandissima parte da giocare nella ricezione e manipolazione di questo patrimonio concettuale, proprio perché l’istituzione carceraria è sempre stata uno dei grandi contenitori scenografici in cui la diegesi narrativa trovava il suo compimento. Sarebbe inutile e riduttivo cercare di stendere qui una tipologia del cinema a tema carcerario, proprio perché si tratta, in realtà, di un universo pluricentrico ed estremamente diversificato sia per quanto riguarda le caratteristiche della struttura narrativa sia per ciò che concerne il grado di presenza che l’istituzione in esame ha all’interno di questi titoli.
Lo scopo di questo contributo è molto più limitato: attraverso l’analisi di due pellicole provenienti da un cinema molto diverso da quello occidentale si vuole presentare un modo diverso di dipingere il carcere e di utilizzarlo in quanto elemento narrativo. Il cinema di Kim Ki-duk si presta molto bene a questo compito, proprio perché alcuni dei suoi film più riusciti sembrano essere legati a doppio filo a questa tematica. Una riflessione di questo genere appare doverosa proprio perché una buona parte del cinema occidentale legato all’universo dei penitenziari appare animato da uno spirito di denuncia che mette a tema le condizioni di vita, quantomeno discutibili, dei reclusi o propone una critica generale verso il sistema giudiziario. È ben vero che esistono anche dei casi in cui questo stereotipo viene ridiscusso e l’immagine della prigione assume valenze inaspettate (come nel caso del film musicale Jailhouse Rock di Richard Thorpe), ma si tratta – a conti fatti - di casi isolati.
Vale quindi senza dubbio la pena di approfondire un’immagine diversa del carcere e del suo universo, attinta dalla filmografia di un regista tanto particolare. Kim Ki-duk infatti, dopo essere emerso presso il grande pubblico con la presenza a Venezia de L’isola nel lontano 2000, ha visto il suo nome imporsi in maniera abbastanza omogenea come quello di uno dei maggiori registi contemporanei, anche prescindendo da alcuni suoi lavori più particolari e meno accessibili come il glaciale Arirang, sorta di video-confessione del regista durante uno dei momenti più bui della sua esistenza. In queste pagine si analizzeranno due pellicole di quella che da molti è giudicata la sua stagione migliore: Ferro 3 - La casa vuota e Soffio. Attraverso una lettura di questi due interessanti lavori cinematografici sarà possibile far emergere una visione particolare dell’istituzione carceraria, forse non sufficientemente esaminata fino ad ora proprio perché non messa sufficientemente a sistema dalla cinematografia occidentale.
MetamorfosiSecondo molti capolavoro insuperato del cineasta coreano, Ferro 3 è un silenzioso affresco in cui viene dipinta, con la maestria assoluta che contraddistingue la composizione dell’inquadratura di Kim Ki-duk, la parabola amorosa fra Tae-Suk e Sun Hwa. Mentre il primo ha la curiosa abitudine di entrare nelle case vuote delle persone (in vacanza o comunque impegnate altrove), la seconda vive rinchiusa nella sua abitazione, vittima di un marito facoltoso ma violento.
Già a questo primitivo livello d’analisi è necessario fare alcune considerazioni interessanti. Innanzitutto non è senza conseguenze la scelta del regista di fare in modo che i due protagonisti non parlassero praticamente mai: questa scelta (che il regista radicalizzerà nel successivo L’arco), oltre ad essere un vero e proprio attentato alla concezione classica del film come storia per immagini, è una chiara dichiarazione di intenti. Soprattutto nel caso di Sun Hwa questo appare particolarmente vero: nonostante le domande del marito, la donna conserverà sempre un silenzio distaccato e assente, che impedirà ai due coniugi qualsiasi forma di comunicazione e condivisione dell’ambiente familiare. Non può quindi non venire in mente uno dei grandi silenzi della narrativa contemporanea, quello del Venerdì di Coetzee. Nella sua riscrittura della vicenda di Robinson Crusoe, l’autore sudafricano ci presenta lo schiavo di Robinson non come un fedele seguace e uno scolaro attento che imparando il linguaggio si civilizza, ma come un rude selvaggio senza lingua refrattario a qualsiasi interazione dialogica. Il silenzio di Venerdì è un estremo tentativo di difesa, di indipendenza, che però al tempo stesso lo rende debole e passabile di riscrittura da parte dei suoi interlocutori (la narratrice Susan Barton, Robinson, lo stesso Coetzee). Tae-Suk e Sun Hwa, “figli del proprio silenzio” (Coetzee 2005: 110) sono, allo stesso modo di Venerdì, delle storie che si promettono ma che non possono venire raccontate nella loro realtà: soltanto i diretti interessati conoscono l’esatto svolgersi di una narrazione, ma se questi ultimi non vogliono o non possono condividere la loro vicenda, la realtà della storia rimarrà sepolta sotto gli strati discorsivi che i poteri avranno proposto come resoconti reali.
Tuttavia, nel corso del film, il silenzio di Sun Hwa si trasforma. Inizialmente possiamo additarle una condizione simile a quella descritta da Levi in merito alla vita nel Lager: “i commandi SS ed i servizi di sicurezza posero poi la massima cura affinché nessun testimone sopravvivesse” (Levi 2007: 5). L’impossibilità di raccontarsi e il suo ostinato silenzio uccidono la verità sepolta dentro Sun Hwa e la riducono a uno stato di larvale passività. Soltanto alla fine del film, quando Tae-Suk tornerà da lei, la donna proferirà parola per la prima volta[2] e, sottraendosi alle concettualizzazioni del marito che non riuscirà a cogliere i motivi profondi di questo atto, assumerà la sua individualità di personaggio narrante.
Fra questi due poli, a preludere alla trasformazione che sostituisce la parola all’afonia, abbiamo proprio la prigione che, alla luce di quanto detto, assume un ruolo fondamentale nell’economia della pellicola. Di prigione, forse, si può parlare anche per quanto riguarda la casa di Sun Hwa, vero e proprio edificio incarcerante, ma il passaggio che ci interessa maggiormente è quello in cui Tae-Suk viene imprigionato ed è costretto a separarsi dall’amata.
Nella sua cella, il nostro protagonista gioca a golf. Il suo è un gesto di mimesi, non avendo a disposizione gli strumenti per praticare questa attività; nonostante ciò il regista sceglie di dare corpo a questo atto puramente mentale facendoci apprezzare, da un punto di vista sonoro, il vibrare della mazza e il rumore della pallina colpita. Questo colloca il gesto di Tae-Suk in uno spazio nuovo che si sottrae a quello meramente materiale della prigione bianca in cui è rinchiuso e ascende ad un piano superiore. Una scelta di questo genere, forse un omaggio alla sequenza finale di Blow Up, ci fa apprezzare una dimensione metafisica che appartiene più generalmente al cinema di Kim Ki-duk e che in questo caso si inscrive proprio nello spazio carcerario.
Ma questo non basta: il desiderio di fuga dalla prigione spinge Tae-Suk a isolarsi, mimetizzandosi sempre di più con l’ambiente fino a rendere la propria presenza impercettibile agli occhi degli addetti alla sorveglianza. Così l’atto di dipingersi un occhio sulla mano [fig.1] “rappresenta un forte desiderio di vedere ma, allo stesso tempo, anche di non voler essere visto” (Chimento 2011: 37). Un’osservazione attenta di questa definizione permette di apprezzare la forma panottica che il personaggio di Tae-Suk si trova ad avere all’interno della struttura del film. Proprio come il dispositivo foucaultiano, il protagonista della vicenda diventa il centro di irraggiamento di un sistema di sguardi di cui gli altri non sono consapevoli. Mentre la sua visione è onnipotente, quella altrui viene continuamente negata. Ecco dunque il primo senso ulteriore che Kim Ki-duk attribuisce alla prigione in quanto istituto: un (non)luogo in grado di generare dispositivi panottici, per così dire, di secondo grado.
Il senso di questa operazione, di questo desiderio di invisibilità è molto chiaro a livello narrativo (la volontà di tornare da Sun Hwa), ma ancora una volta lo si può leggere in un modo ulteriore, più complesso e metafisico.
In maniera simile ma diversa dal discepolo divenuto uomo di Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera, Tae-suk si allena nel corpo e nello spirito per rinascere a nuova vita, trovando con ciò la sua dimensione ideale, il suo vero posto nel mondo che è – ancora una volta – un non-posto […] per Taesuk è una forma di presenza-assenza, in cui egli è come un fantasma, invisibile alla vista altrui. Una condizione che gli consente di vivere la condivisione con altri del medesimo spazio, senza più attriti. (Renzi 2005: 62-3).
Dunque Tae-Suk esce dalla prigione come un’ombra, un panottico invisibile che (presumibilmente) da quel momento in poi condurrà la sua esistenza in maniera spettrale eppure profondamente armonica nei confronti di chi inconsapevolmente condividerà i suoi spazi. Il percorso apertosi con l’ouverture del film è dunque completo: Tae-Suk ha acquisito la consapevolezza e la tecnica necessaria per scomparire pur stando in mezzo agli altri individui, perfezionando il suo goffo modo di vivere precedente, che lo costringeva a subitanee e pericolose fughe. Centro nevralgico di questo cambiamento è stato proprio l’istituto detentivo che, come per molti altri elementi del cinema di Kim, risulta come trasumanato in una dimensione ulteriore, che fa assurgere il protagonista a una nuova esistenza.
ApertureL’acquisizione principale derivante dalla nostra analisi di Ferro 3 – La casa vuota rimane l’idea di una prigione rappresentata come un luogo irreale. La cella (questo è, in effetti, quanto si vede del carcere) diventa un elemento narrativo e fisico di passaggio, di unione fra due dimensioni apparentemente inconciliabili. Da una parte abbiamo il mondo fenomenico, con il suo antideterminismo (che fa ad esempio in modo che Tae-Suk e Sun Hwa vengano scoperti dai parenti di un anziano defunto) e dall’altra un mondo “altro”, dal sapore quasi onirico, verso cui Tae-Suk riesce ad elevarsi per assurgere alla sua piena umanità. Così come Sun Hwa alla fine uscirà dal suo silenzio raggiungendo la piena dignità narrativa, così Tae-Suk realizzerà la sua funzione di silenziosa empatia [fig.2]; la cella è, in questo sistema di evoluzioni, il luogo cardine, il centro della metamorfosi.
Diverso è il discorso per Soffio, presentato in concorso al Festival di Cannes del 2007. In quest’opera l’ambiente della prigione si impone sin da subito nella sua accezione più materiale e tutto il film orbita concretamente attorno a una prigione di Stato. Una delle primissime inquadrature è, da questo punto di vista, esemplare. In una cella del suddetto penitenziario, un carcerato è intento a scolpire con uno spazzolino appuntito il corpo di una donna sopra l’immagine di Buddha, nel vano tentativo di rendere lo spazio più abitabile. Un suo compagno di cella, Jang Jin, sottrattogli l’utensile, lo utilizza come arma per tentare il suicido, conficcandoselo nel collo. Le urla di un terzo compagno scuotono tutta la prigione. Il modo in cui Kim Ki-duk decide di rappresentare questa scena è esemplare: mentre il condannato urla, il regista riprende il corridoio della prigione, apparentemente senza fine, con le celle tutte uguali. In queste condizioni per le guardie (e per lo spettatore) è ben difficile dire da quale cella provenga quell’urlo lacerante. Ecco dunque una prima immagine del sistema carcerario nel suo complesso, questa volta fortemente concreta: la prigione diventa un sistema uditivo isomorfo rispetto al panottico. Esiste un sistema di suoni, oltre che di immagini, di incerta provenienza all’interno dei sistemi disciplinari: tutti ascoltano, ma nessuno è in grado di decodificare l’origine di uno stimolo che, in ultima analisi, rimane acusmatico.
Apparentemente le cose non potrebbero essere più diverse rispetto a quanto detto per Ferro 3, ma le continuità non mancano. Anche in questo caso abbiamo una protagonista (la casalinga Yeon) che, nel suo ambiente domestico, è ridotta al silenzio. La sua condizione è più simile a quella del già citato Venerdì di Coetzee rispetto a quella di Sun Hwa. Il suo pertinace rifiuto di instaurare un dialogo con il marito (che verrà meno solo alla fine del film) è al contempo un’arma e un meccanismo di difesa. Schiacciata dalla sua depressione, causata anche dai tradimenti del marito, ella sfida continuamente il suo consorte con uno sguardo glaciale ed assente, un monito perpetuo al ricordo della colpa. Di nuovo ritorna, dunque, lo snodo narrativo della casa/prigione che si aveva avuto modo di apprezzare in Ferro 3.
Il tentativo di Yeon di affrontare i suoi demoni passerà proprio attraverso le mura della prigione nel cui braccio della morte è rinchiuso l’altrettanto silenzioso Jang Jin (il quale, però, lo è a causa delle lesioni alle corde vocali riportate in seguito al tentativo di suicidio). Spacciandosi per l’ex-fidanzata del detenuto la donna riuscirà a introdursi nel penitenziario e a parlare con lui. Tutte le tappe del suo permanere all’interno della struttura detentiva sono rigidamente regolate da un regista invisibile, un ipotetico capo della sorveglianza che, attraverso i suoi monitor, controlla i movimenti della donna, ne autorizza il passaggio e ha l’ultima parola in merito alla durata dei suoi incontri con Jang Jin. Questo oscuro personaggio, di cui vediamo solo l’immagine riflessa nei monitor della sorveglianza, è lo stesso Kim Ki-duk che, riprendendo una tradizione variamente fortunata del cinema, entra in prima persona nel suo film. Così Kim, regista di Soffio, è anche regista di ciò che accade all’interno della prigione. I suoi poteri di gestione sono infatti pressoché illimitati, almeno a quanto c’è dato vedere. Questo Dio che accorda o nega il suo volere a ciò che avviene dentro la struttura è dunque lo sguardo sovrano del panottico foucaultiano, colui che guarda senza essere visto, il Grande Fratello. La cosa è particolarmente interessante e andrebbe approfondita: come il panottico è uno sguardo che non si mostra, così il cinema (è forse questo che Kim vuole dirci?) è una macchina voyeuristica attraverso la quale lo spettatore scruta, senza difficoltà, in un'altra dimensione, dove gli individui non sanno di essere osservati. Per com’è strutturato un certo cinema, fortemente narrativo e lineare, la cosa potrebbe anche avere una sua validità.
Un altro elemento fondamentale per definire il senso che la prigione ha in Soffio sono, ovviamente, i momenti di incontro tra Yeon e Jang Jin. Tralasciando la prima occasione di dialogo, non utile per i nostri scopi, ci sono almeno tre episodi significativi da considerare. Nonostante la diegesi si dipani lungo un arco temporale che possiamo immaginare localizzato ai prodromi dell’inverno, Yeon “porta” le stagioni nella prigione. Prendiamo in considerazione il secondo incontro fra i due, esemplare da questo punto di vista: Yeon si reca al carcere con dei rotoli di carta da parati, una radio portatile e qualche altro oggetto; sempre grazie al benestare del sorvegliante/regista Kim, la donna riesce ad avere carta bianca e trasforma il parlatorio in una rappresentazione della primavera [fig.3]. L'opera si compie quando, all’ingresso del detenuto, Yeon intona alcune strofe sulla stagione che ha deciso di inscenare. Nel semplice gesto della protagonista si consuma un atto massimamente eversivo nei confronti dell’istituzione carceraria classicamente intesa: alla claustrofobia della reclusione si sostituisce un’apertura verso un altro spazio. Poco importa la natura finzionale dell’operazione: la castigata nudità delle pareti è stata messa da parte e tanto basta per Jang Jin.
Il carcere è di norma un luogo immutabile e sempre uguale a sé stesso, non intaccato dalle mutevoli condizioni esterne. La sospensione temporale che avvolge la prigione viene rotta da Yeon che vi inserisce, con la sua fantasiosa trovata, delle discontinuità fortemente eversive che riescono a mettere in contatto Jang Jin con l’esterno, con il continuo avvicendarsi del tempo. L’efficacia della strategia di Yeon è provata dal progressivo abbandonarsi del condannato all’evidenza del tempo ricostruito, dal suo perdersi in una volontaria illusione che però è in grado di restituirgli il senso della "durata" e, quindi, il senso dell’esistenza. Così, quando è l’autunno ad essere ricostruito [fig.4] e le foglie fiammeggianti fanno da sfondo al loro incontro, Jang Jin non può che avvincersi all’abbraccio di Yeon.
Questo ci autorizza a parlare ancora una volta del carcere di Kim come di uno spazio mentale, metafisico che, sebbene sia rappresentato con tutto il realismo del caso (i tentativi di suicido di Jang Jin non risparmiano dettagli vagamente cruenti), non può non aprirsi a dimensioni ulteriori che rifuggano dal senso dell’esistenza fenomenica. L’immaginazione di Jang Jin, stimolata dalla fantasiosa ricostruzione di Yeon, gli permette di considerare il carcere in senso nuovo, come un crocevia di mondi possibili in cui egli crede legittimamente di trovarsi (concedendo alla finzione della donna una fiducia non dissimile da quella che lo spettatore accorda all’immagine cinematografica)[3].
Anche la finzione però è destinata a finire. Come un film ha i suoi titoli di coda così la messa in scena di Yeon si concluderà con la mancata rappresentazione dell’inverno. Nessuna carta da parati innevata trasformerà le pareti del parlatorio, nessuna canzone strapperà un sorriso a Jang Jin. L’ultimo incontro dei due amanti è semplicemente un atto sessuale potenzialmente mortale (Yeon cerca di soffocare Jang Jin), mentre l’inverno vero e proprio imperversa all’esterno e all’interno della prigione. Fuori dalle mura dell’istituto carcerario il marito e la figlia di Yeon giocano in mezzo alla neve, mentre l’interno del parlatorio freddo e livido non può che ricordare la glacialità della stagione invernale. Non c’è rappresentazione, non c’è messa in scena perché l’inverno è già arrivato e perché la prigione fredda e inospitale che ora si rivela nella sua essenza lo rappresenta già a sufficienza. La finzione si conclude ed emerge la verità: mentre Yeon torna dalla sua famiglia, durante la notte Jang Jin viene soffocato da un compagno di cella.
ConclusioniDurante l’analisi dei due film di Kim Ki-duk, lo studio ha evidenziato soprattutto il modo del tutto particolare che il metamorfico cineasta coreano ha di rappresentare l’universo carcerario. Rispetto a una tradizione occidentale che ha sempre dipinto la prigione come un mondo chiuso, asfittico, da cui fuggire, in Ferro 3 e Soffio l’istituto detentivo diventa uno spazio magmatico, che si trasforma e trasforma chi vi si trova. Se in Ferro 3 la cella era il luogo d’incubazione di una rinascita dal sapore metafisico, in Soffio l’intero sistema viene chiamato in causa e trasformato in un luogo di congiunzione fra spazi esterni diversi.
Il tradimento rispetto al tradizionale immaginario della prigione diventa per Kim Ki-duk una modalità espressiva finalizzata ad alimentare una vena che sottende tutto il suo cinema e che trova la sua massima realizzazione proprio nell’elevazione ultrafenomenica degli elementi del vissuto comune, cosa che ci viene confermata, ad esempio, anche dal suo ultimo e splendido Pietà. Siamo di fronte ad una visione complessa che nel caso della prigione, sebbene non rinunci a confrontarsi con la communis opinio in merito, contribuisce senza dubbio a ridiscuterla nel profondo.
BibliografiaCHIMENTO A. (2011), “Eterotopia della prigione. Due esempi dal cinema dell’estremo Oriente” in Comunicazioni sociali, 4.
COETZEE J. M. (2005), Foe, Einaudi, Torino.
FOUCAULT M. (1993), Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino.
LEVI P. (2007), I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino.
ORWELL G. (2009), 1984, Mondadori, Milano.
PEZZELLA M. (2010), Estetica del cinema, Il Mulino, Bologna.
RENZI V. (2005), Il cinema di Kim Ki-duk, Dino Audino, Roma.
[1] Mutuiamo l’espressione da Mario Pezzella che, a proposito della visione cinematografica, parla proprio di un voyeurismo assoluto in cui c’è una netta “mancanza di reciprocità fra chi è visto” (Pezzella 2010: 68).
[2] Il fatto che la prima battuta della protagonista femminile del film sia situata alla conclusione della vicenda è, ovviamente, un altro attacco molto profondo all’idea del film come contenitore narrativo.
[3] Un’operazione non dissimile da questa è stata presentata anche nel film Il bacio della donna ragno (Hector Barbenco, 1985), adattamento dell’omonimo romanzo di Manuel Puig, in cui l’omosessuale Molina racconta al compagno di cella Valentin un film ambientato ai tempi della Seconda guerra mondiale. Anche in questo caso possiamo quindi parlare di un’intromissione extra-diegetica di una dimensione “altra” rispetto al carcere, con la differenza che nel film di Kim Ki-duk l’effetto è rafforzato incredibilmente dal fatto che la realtà altra è concreta e si situa proprio all’interno delle mura carcerarie.

Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza
Copyright (c) 2023 Elephant & Castle

TQuesto lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.